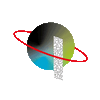Alto Adige - cronaca di un'estinzione - La turbolenza #0
Come si sopravvive all'estinzione di un'idea di se stessi e del proprio mondo? Alcuni appunti sullo choc culturale della pandemia in Alto Adige.

Intervistato dal quotidiano Alto Adige, Erwin Hintereggr, CEO di IDM, potentissima agenzia di marketing territoriale che controlla il brand Alto Adige, parlandone in modalità damage control lo definisce un "grave danno d'immagine" e un "problema di reputazione da recuperare".
Oggetto della sua costernazione è l'elevato numero di persone che, in Provincia di Bolzano, hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV2, che da due anni imperversa per il mondo, mettendo alla prova la tenuta di molte società, soprattutto in Occidente.
Nel mirino delle preoccupazioni di Hinteregger c'è la buona riuscita della stagione turistica invernale che, dopo un anno, appare ancora a rischio dal momento che la provincia si trova attualmente in bilico tra la zona gialla e quella arancione.
A dominare il panorama è un diffuso senso di incertezza, amplificato da una copertura mediatica nazionale e internazionale tutt'altro che lusinghiera. Incertezza che sta avendo un duplice effetto sul comparto turistico: da una parte ci sono le numerose disdette registrate dagli operatori e dall'altra le prenotazioni che stentano a decollare, alimentandone la preoccupazione.
Per rendersi conto che anche questa si prospetta una stagione difficile bastava passeggiare per il centro di Bolzano durante il ponte dell'Immacolata. In quella che, per tradizione, è una delle festività chiave per il turismo invernale legato ai mercatini di Natale la città appariva stranamente calma e compassata.
A chi scrive però, quello che per Hinteregger è soprattutto un problema di PR, da risolvere attraverso "una revisione dell'apparato di comunicazione di IDM", appare come qualcosa di più profondo e prende i tratti più complessi e sfumati dello shock culturale.
Per capire perché è opportuno fare una digressione lunga quasi due anni.
La via sudtirolese alla pandemia
All'inizio del 2020, quando lo spettro del SARS-CoV2 cominciava a manifestarsi in Italia, apparendo tra lo sbigottimento generale dall'altrove orientalista in cui era originariamente apparso, il presidente della locale Camera di Commercio, che è anche l'imprenditore che controlla da una posizione di quasi monopolio la maggior parte dell'informazione della provincia, dichiarava, a proposito del diffondersi del Coronavirus, che
se si analizzano i numeri in modo obiettivo, si scopre che in Alto Adige il rischio di contagio è minimo, indipendentemente dal fatto che nei prossimi giorni sorgano o meno altri casi isolati. Anche se si venisse contagiati, in nove casi su dieci il decorso della malattia non è preoccupante. Non c'è quindi motivo di disperare. Gli effetti psicologici ed economici del Coronavirus sono molto più pesanti della malattia stessa. La vita e il lavoro devono continuare.
L'inconsistenza e la protervia di un'affermazione del genere divennero evidenti quando, poche settimane dopo, i contagi erano esplosi in tutta la Provincia di Bolzano e alcune delle principali località turistiche del territorio - la Val Gardena in testa a tutte - si erano trasformate in focolai di considerevole entità. In quei giorni di marzo in un'intervista pubblicata su salto.bz, Massimo Ribetto, referente regionale del sindacato degli infermieri Nursing up, dichiarava che
la percezione è che l’Alto Adige sia rimasto indietro, di almeno una settimana, rispetto al resto d’Italia e che non si stia facendo abbastanza.
Ciononostante, e a dispetto di questa e altre cautonary tales che tennero banco nelle cronache di quei primi giorni di pandemia, la gestione dell'emergenza da parte del sistema Alto Adige fu improntata fin da subito verso una "via sudtirolese alla pandemia".
In contrasto con il governo centrale e in anticipo rispetto al resto d'Italia, la Provincia di Bolzano, appoggiandosi allo Statuto di Autonomia, è stata la prima a riaprire le attività. Questa dinamica conflittuale da una parte sembrava guardare alla storia turbolenta del rapporto Alto Adige e Italia, dall'altra parte appariva però più come un gioco delle parti che permettesse al governo locale di procedere lungo la sua strada senza che quello nazionale perdesse la faccia, e dunque il controllo, sul resto del territorio
Con l'arrivo dell'estate 2020, sempre in anticipo rispetto al contesto e per non turbare l'idillio dei turisti, la Provincia di Bolzano è stata tra le prime ad allentare le restrizioni, alimentando l'idea che il peggio fosse passato, salvo poi trovarsi, impreparata, ad affrontare, all'inizio dell'autunno successivo, la seconda ondata.
Anche in questo caso la reazione è stata lenta, caratterizzata da tentennamenti e inefficace.
Si è così arrivati alla mezza farsa del test di massa del novembre 2020, la cui efficacia è stata minata fin dall'inizio dalla fretta di riaprire per "salvare il Natale", che nel giro di due mesi e in piena terza ondata ha riportato la provincia in zona rossa, proprio mentre il resto del paese usciva, lentamente e a fatica, dalle restrizioni.
A conti fatti, La "via sudtirolese alla pandemia" - la convinzione che le doti di organizzazione e diligenza che fanno parte dell'identità e dell'autorappresentazione della popolazione altoatesina sarebbero, da sole, bastate a gestire la crisi in modo più efficace e con un decorso più rapido rispetto al resto del contesto nazionale e internazionale - si è rilevata infatti fallimentare e inefficace.
In questo fallimento risiede il primo nucleo dello shock culturale che ha scosso e scuote ancora la psiche collettiva degli abitanti della provincia di Bolzano, mettendo in discussione fino a fratturarla un immagine di sé consolidata nel corso di decenni e che appariva intoccabile solo fino a pochi mesi fa.
È stato proprio mentre questa consapevolezza cominciava a depositarsi nel corpo collettivo altoatesino che un altro fenomeno di grande portata cominciava a far sentire la propria presenza sul territorio.
L'Alto Adige e il rifiuto del vaccino
In ritardo rispetto al resto del paese, l'Alto Adige ha vissuto gli echi del movimento "Io apro" quando, all'inizio del gennaio del 2021, si è tornati a parlare di chiusure. In quei giorni furono chiamate un paio di manifestazioni discretamente partecipate, almeno per un territorio poco o nulla incline a questo genere di forme di protesta.
Ad attraversare quelle piazze erano soprattutto e in modo più evidente albergatori e ristoratori preoccupati di dover chiudere ancora una volta. A quel tempo era ancora lo spettro di un nuovo lockdown - che sarebbe comunque arrivato - a dover essere esorcizzato. Eppure, facendo attenzione e muovendosi tra gruppi Facebook e chat Telegram, ci si poteva accorgere che l'ombra di una nuova minaccia stava profilandosi all'orizzonte: quella del vaccino e, poco dopo, quella del passaporto vaccinale.
Quella di Bolzano è stata infatti tra le prima province italiane ad avviare la campagna vaccinale e ad adottare un pass, il cosiddetto Corona Pass, mutuato da analoghe iniziative prese nel mondo tedesco, da sempre punto di riferimento privilegiato per l'Alto Adige.
L'opposizione a queste misure inizia perciò a farsi sentire con un certo anticipo rispetto al resto d'Italia e d'Europa. Già alla fine dell'inverno, a Bolzano, Bressanone e Brunico, vengono organizzate le prime, poco partecipate, "passeggiate per la libertà". In primavera appaiono affissioni contro il pass vaccinale e vengono organizzate manifestazioni di protesta che hanno il rifiuto del vaccino come argomento centrale.
Una delle voci più in vista di quel movimento, l'avvocatessa Renate Holzeisen, guadagnerà proprio in quei mesi anche un piccolo credito di fama nazionale partecipando ad alcuni "dibattiti" televisivi.
Candidata all'elezioni europee per il Team K, spin off locale del Movimento 5 Stelle capace, nel 2018, di prendere il 15,2% dei voti alla sua prima partecipazione alle elezioni Provinciali, Holzeisen è da tempo impegnata in prima persona a sostenere la causa dei sanitari sospesi per il rifiuto della vaccinazione.
Nonostante sembri aver perso forza e voce proprio mentre nel resto d'Italia, tra l'assalto alla CGIL e la sommossa di Trieste, esplodeva la protesta contro il Green Pass e il vaccino, va comunque evidenziato come questo movimento rappresenti al momento circa il 15% della popolazione vaccinabile della Provincia di Bolzano che è il terzo territorio meno vaccinato d'Italia, secondo solo a Sicilia e Calabria.
Come abbiamo già visto, è a questa irriducibilità che faceva riferimento Hinteregger quando parlava di un danno di reputazione. Ma è interessante tornare alle sue parole a questo punto, perché quando gli viene chiesto cosa intenda per reputazione, il CEO di IDM risponde:
beh, una lunga tradizione di rispetto delle regole, di attenzione al benessere loro e anche dei nostri ospiti.
A partire da queste parole possiamo iniziare a delineare il secondo nodo dello shock culturale che sto cercando di mettere a fuoco. Se il fallimento della via sudtirolese alla pandemia aveva messo in discussione l'eccezionalismo dello spirito sudtirolese, la sua capacità di organizzazione e la sua diligenza, l'ostinato rifiuto del vaccino ne sta facendo riemergere quel lato ribelle e irriducibile che ha nella mitologia di Andreas Hofer il suo mito fondativo.
Non è un caso se proprio la figura di Hofer ha campeggiato, per molti mesi e accompagnata da un'invettiva contro il lockdown, sulla facciata dell'hotel Cavallino Bianco di San Candido, salito quest'estate agli onori della cronaca nazionale per il divieto di usare la mascherina, imposto dal titolare ai suoi dipendenti.
Ma l'effetto di tale rifiuto va molto più in profondità rispetto all'evocazione di miti tecnicizzati come quello di Hofer. La frattura che attraversa oggi la società altoatesina, polarizzandola con violenza intorno alla dicotmia no vax/si vax, la fa distribuendosi in modo trasversale rispetto alle linee di appartenenza etnica, rompendo (e per questa suggestione ringrazio l'amico Valentino Liberto, che me l'ha suggerita) quel senso di unità che era emerso come reazione a un altro, enorme shock culturale, le Opzioni, e che per decenni ha fatto da collante per la popolazione di madrelingua tedesca.
Questo non significa né dimostra che il conflitto etnico sia stato in alcun modo superato. Esso è comunque presente come rimosso, come spettro che infesta ogni aspetto della nostra psiche collettiva. Di fatto ritorna nella narrativa che, rispetto all'accettazione del vaccino e al rispetto delle regole, opporrebbe la popolazione italiana a quella tedesca. Per la prima un'occasione ghiotta, quand'anche Angela Merkel nel suo discorso d'addio ammette di desiderare che "anche la Germania fosse come l'Italia", per fare i conti con il suo senso di inferiorità rispetto alla controparte e riscoprirsi, proprio nell'anno degli straordinari successi sportivi internazionali italiani, migliore e più ligia alle regole dei propri vicini.
La realtà dei fatti, sotto a questi conflitti d'identità che stanno ancora a ricordarci come, a dispetto della pacificazione, lo scontro entico sia una ferita che ancora suppura, è più sfocata e dai contorni meno netti. Piuttosto è interessante notare come la dicomotia no vax/si vax riprenda quella tendenza di scontro tra la cultura urbana, progressista e cosmopolita, e quella rurale, conservatrice e suprematista, che è uno dei tratti più evidenti della nuova cultura globale. Per accorgersene basta girare lo sguardo verso gli Stati Uniti nel crepuscolo trumpiano, dove le campagne in armi hanno letteralmente e più volte invase le città in tumulto dopo l'uccisione di George Floyd.
Cosa fare quando una società si estingue?
Quando e se la pandemia finirà le cose non torneranno come erano prima. Questa è un'illusione determinata dal regime discorsivo con cui tutto questo trauma è stato gestito nei suoi primi istanti. Non torneremo ad abbracciarci domani o, se lo faremo, non saremo più gli stessi che si erano allontanati per restare al sicuro.
Quello che stiamo vivendo nella terra in cui sono nato e vivo e che ho provato a raccontare con questi appunti brevi e disordinati, che avrebbero bisogno, per essere utili davvero, di un'elaborazione collettiva e urgente di cui oggi non vedo alcuna possibilità, è l'estinzione di una società, la scomparsa di un'autorappresentazione che ci ha accompagnati, determinati e tenuti insieme come società per decenni.
Non credo a chi dice che, passato tutto, le persone si dimenticheranno di quanto è successo, perché, si sa, le persone hanno la memoria corta. La magnitudo del trauma è stata enorme e, senza un'elaborazione, senza il lavoro della ripetizione che lo mitighi e lo rimodelli per dare vita a nuove energie, le ferite che ha generato non si chiuderanno.
Questo non vuol dire che ci saranno necessariamente dinamiche di causa-effetto. Forse non vedremo inaspettati risultati elettorali, rivoluzioni o la rovina delle istituzioni di oggi. I simulacri del potere e dell'identità sopravvivono al crollo e si preservano nel tempo senza che il loro funzionamento ne venga intaccato. Ma intorno a loro tutto scorre e cambia e, giorno dopo giorno, sfugge alla loro presa e le lascia indietro, vuote e inutili come acquedotti diroccati in un paesaggio di rovine.
Ma come si sopravvive all'estinzione? Come si vive all'ombra del disastro? Come si attraversa la zona morta?
Io non ho queste risposte, ma sono convinto, e mi spiace per Hinteregger, che non basti "intensificare proprio adesso una comunicazione più realistica e rassicurante", che non sia sufficiente "tirarsi su le maniche e raccontare le persone, i bar aperti, i gestori degli impianti", che la chiave non sia "comunicare, comunicare" quando stiamo perdendo l'immagine di noi stessi e le parole per dirci.
Perciò mi affido a un libro. S'intitola Cronache della grande estinzione. È il frutto di un lavoro collettivo coordinato da Matteo Meschiari e Antonio Vena, che ne hanno fatto un manuale di sopravvivenza per tempi oscuri, compendiando la grande mole di letteratura esistente sulla morte delle società, gli shock culturali e i cigni neri attraverso una selezione di racconti che sperimentano un linguaggio in grado di attraversare la catastrofe per traghettarci oltre di essa.
Ecco, il punto è questo ed è il compito che, credo, ci aspetta oggi. Abbiamo da inventare un linguaggio che ci porti oltre la catastrofe. Abbiamo bisogno di nuove storie e nuove immagini. Di nuovi miti da raccontare quando, rifugiato in fuga, noi sopravvissuti ci stringeremo intorno al fuoco e, coi nostri occhi spaventati, cercheremo qualcosa che ci protegga dall'oscurità in agguato.
Se saremo all'altezza, beh, questo non so dirlo, ma non c'è molto che mi dia fiducia oggi.
🌪️ Che cos'è la turbolenza?
La turbolenza è il diario di lavoro di un libro su come la cultura globale si riflette nella politica altoatesina. Un modo per pensare in pubblico e condividere con te leggi gli appunti che prendo durante la strada.
Leggi anche le altre puntate della serie.☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️
Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.
Offrimi un caffè!