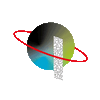Il mito tossico dell’influencer politico
Cosa possiamo imparare sul rapporto tra spettacolo e politica dalla pubblicazione delle chat di Vagnoli, Fonte e Sabene?

Ti rassicuro; se un giorno qualcuno frugasse nelle mie chat private, difficilmente ne caverebbe “salsa” alla Lucarelli. Mi premuro di far questa premessa, perché il mood degli ultimi giorni è stato un continuo “se leggono le mie chat private, finisco torturato dalla Wagner”.
Non vorrei dirtelo io, ma se hai superato i 35 e ti vergogni di quello che mandi o scrivi in chat, forse un paio di domande dovresti fartele.
In ogni caso, se non ti comporti da stronzo dovresti poter dormire sonni tranquilli. I rischi che le tue chat finiscano nel fascicolo di un’indagine sono, per la stragrande maggioranza delle persone, virtualmente nulli.
E, ultimo viene il corvo, indignarti perché una giornalista ha fonti dentro le procure è ingenuo: la carte girano, a meno che tu non viva nel paese dei Teletubbies. Ne sono arrivate perfino a me, che sono solo un povero stronzo e nemmeno mi occupo di cronaca.
Dopo aver messo da parte il chiacchiericcio, se sei arrivato fino a qui e ti sei chiesto “Flavio, ma di che cazzo stai parlando?”, è il tempo di un breve riassunto.
La notizia che ha scosso la mia bolla la scorsa settimana è che Selvaggia Lucarelli ha pubblicato estratti da alcune chat private tra Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, influencer femministe con riconoscibili profili pubblici.
Le chat fanno parte di un’inchiesta in cui le tre sono indagate di stalking, in seguito a due denunce: la prima sporta dalla social media strategist Serena Mazzini e la seconda da un uomo, che denuncia comportamenti vessatori dopo la fine della sua relazione con Sabene.
Questi i fatti, di cui però non mi interessa parlare oltre.
Quello che mi interessa mettere sotto ai riflettori qui è un problema che mi sta a cuore: il modo in cui l’attivismo degli influencer danneggia la politica, in particolare quella di sinistra.
Per mostrarlo bisogna analizzare la merce che un influencer produce e scambia per ottenere in cambio visibilità e denaro: il contenuto.
Secondo Kate Eichorn, che al contenuto ha dedicato un libro tanto agile quanto utile, il contenuto è un elemento digitale che circola in rete. Esso è onnipresente, scalabile all’infinito e non richiede una relazione diretta con l’informazione.
Anche se non ne contiene alcuna, e dunque non trasmette alcuna conoscenza, un contenuto può funzionare lo stesso, perché la sua funzione principale è la sua circolazione.
A prescindere dal fatto che venga fruito, il senso di un contenuto può esaurirsi nella sua trasmissione. È questa capacità trasmettere contenuti che crea il valore di un influencer.
Più i contenuti che produce si diffondono, più l’influencer accumula capitale in tutte le sue forme: culturale, sociale, simbolico ed economico.
Negli ultimi dieci anni, infatti, le aziende tecnologiche hanno compreso che la creator economy è la chiave per fidelizzare gli utenti e tenerli il più a lungo all’interno delle loro piattaforme.
Sottoposta a queste spinte, la rete, nata come spazio di relazioni orizzontali, si sta trasformando in un luogo caratterizzato da relazioni sempre più verticali.
Uno scenario dominato da nodi di grandi dimensioni, attorno a cui si aggregano ampie platee di seguaci che, spesso, si limitano a fruire di contenuti senza produrne a sua volta.
Non credo sia la fine del prosuming, ma è evidente che quella che vent’anni fa era una funzione chiave della rete stia subendo una profonda ristrutturazione, in cui l’equilibrio tra consumo e produzione tende a sfavorire di quest’ultima.
Perché questo meccanismo è problematico da una prospettiva politica di sinistra?
Prima di tutto perché un politica di sinistra dovrebbe puntare a costruire una dimensione di massa in cui i singoli individui possano esprimere la loro comune coscienza di classe.
Per quanto possa essere orientata a un orizzonte politico, la produzione di contenuto non equivale a fare politica.
In essa, la massa non esiste in quanto espressione della coscienza di classe degli individui; esiste in forma di pubblico - seguito o community a seconda del tasso di coinvolgimento - nei cui confronti l’influencer agisce insieme da magnete e da principio di selezione statistica in grado di far emergere segmenti target.
Da questo lavorio, l’influencer trae legittimazione come profilo pubblico e, attraverso tale legittimazione, può rappresentarsi - o essere rappresentato - come portavoce di un soggetto collettivo che non è solo costituito dal suo seguito ma anche dall’intero segmento di persone derivabile dall’analisi di quest’ultimo.
È per questo motivo che Lucarelli può prendere la vicenda che racconta nel suo articolo, generalizzarla e usarla per attaccare il femminismo radicale nel suo insieme, usando ambiguità, contraddizioni e idiosincrasie individuali come metonimia per un soggetto collettivo.
Il problema di questa rappresentazione è che ha una natura illusoria. In realtà, a parte se stesso in quanto proprietario di un’infrastruttura di produzione di contenuti, l’influencer non rappresenta nessun’altro.
I numeri con cui rivendica la sua influenza, infatti, misurano più che altro l’estensione della sua rete, non la capacità di attivarla.
Il magro risultato che la Lega ha ottenuto alle elezioni regionali in Toscana non racconta solo di una debolezza strutturale del partito. Racconta anche di quanto sia limitata la capacità d’influenza di un personaggio ipermediatico come Vannacci e di come la natura degli influencer non sia facile da comprendere.
Più che guardar loro come dei ripetitori in grado di amplificare un messaggio, bisognerebbe intenderli come rilevatori d’opinione che funzionano a ciclo continuo.
A pensarci bene è quanto ha fatto Trump e il suo apparato con gli influencer dell’alt right.
Invece che provare a cooptarli come megafono per la macchina del partito, li ha usati come cartina al tornasole di un sentire e ha adattato per loro i suoi messaggi, lasciando che fossero gli influencer stessi a farli propri, a rielaborarli e a diffonderli presso i loro seguaci.
In un certo senso, Trump li ha lasciati liberi di occupare una scena di cui lui poteva permettersi di non essere la star, o di esserlo per interposta persona.
Per poter funzionare, infatti, gli influencer hanno bisogno di attenzione costante e di utenti tanto fedeli quanto fidelizzati, a cui fare da specchio.
Questa dipendenza dall’attenzione impone loro di bilanciare il culto della propria personalità, cercando attenzione da chi è percepito come più influente di loro, ma pronti a rivoltarglisi contro se e quando smette di considerarli.
È questa loro volatilità che li rende una presenza ingombrante dal punto di vista politico.
Senza un’infrastruttura organizzata che possa gestirla, il rischio è che gli influencer crescano al punto da mettere a repentaglio l’efficacia dell’azione politica più che costituire una risorsa da usare a vantaggio di un soggetto collettivo.
Chef Rubio è il primo esempio che mi viene in mente per descrivere questa dinamica. Il conduttore di Unti e Bisunti ha avuto agibilità nei centri sociali in virtù delle sue posizioni a sostegno della causa palestinese.
Col tempo, però, le sue prese di posizione estreme sono diventate imbarazzanti, difficili da gestire e, soprattutto, traslate e generalizzate su soggetti collettivi alla cui attività politica l’influencer non prendeva parte in alcun modo.
Una dinamica simile accade con personaggi come Orsini o Barbero.
Influencer apprezzati a sinistra per il modo in cui hanno rappresentato posizioni percepite come alternative a un mainstream a cui pure appartengono, ma che sul piano politico non rispondono ad altri se non a se stessi.
Ognuna di queste figure agisce infatti all’interno di una dimensione spettacolare. Il loro orizzonte non è l’azione politica collettiva, ma la riproduzione incessante della propria immagine nel ciclo di produzione del contenuto.
Occorre tenerlo a mente, se non si vogliono prendere dolorosi abbagli.
La prossima volta che un profilo “di riferimento” esplode nel feed, proviamo a chiederici se parla per sé o per un soggetto organizzato? Se attiva o è coinvolto in situazioni al di fuori dallo schermo o del palco su cui si esibisce? Se accetta vincoli e responsabilità condivise?
Se la risposta è no, sta facendo spettacolo. Non politica.
☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️
Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.
Offrimi un caffè!