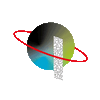La lunga estate dell'overtourism - La turbolenza #5
Una riflessione intorno al dibattito su turismo di massa in Alto Adige.
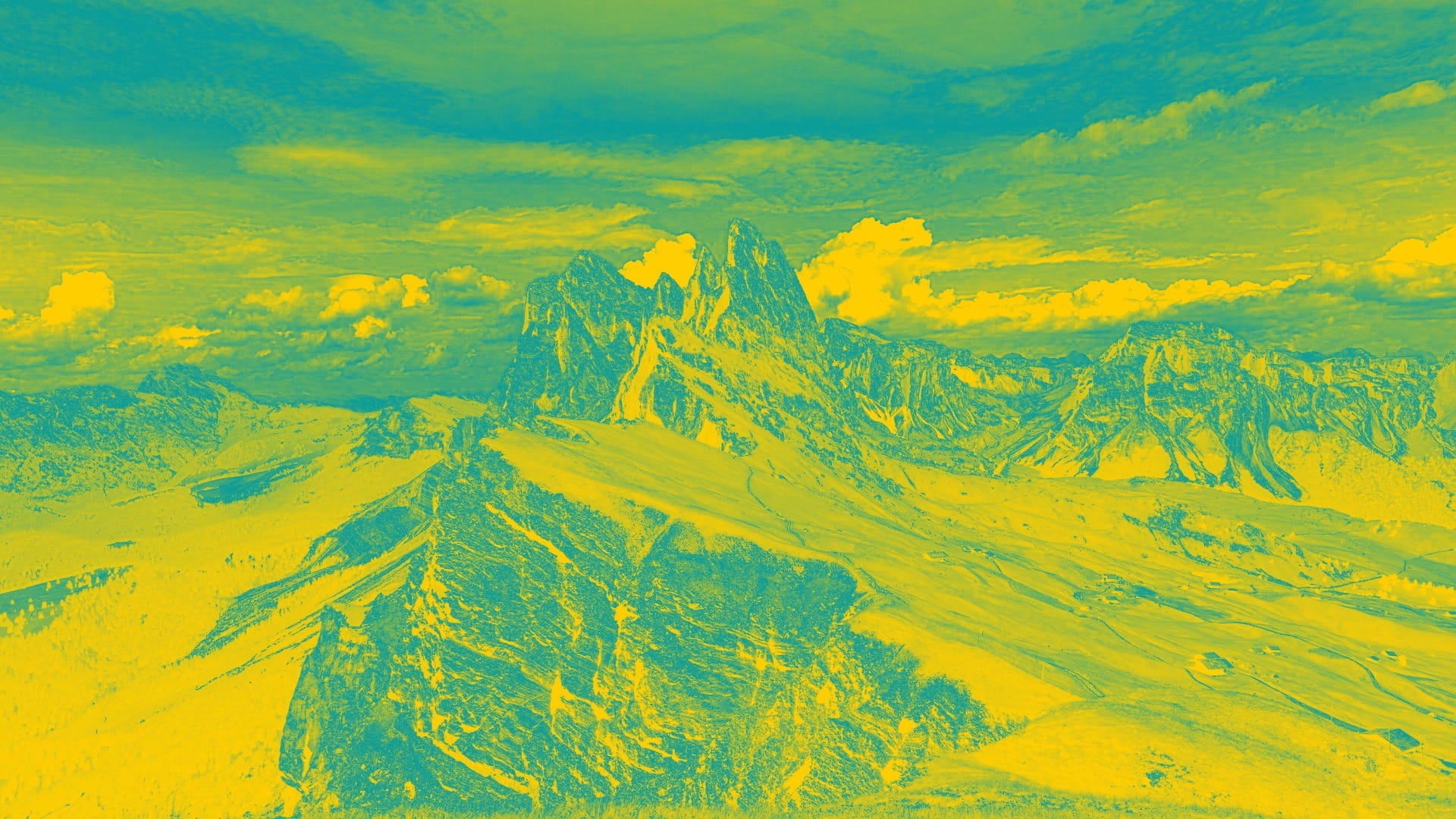
Galeotto fu un tornello e chi lo ha installato. Se hai seguito le cronache estive probabilmente sai che sto parlando di quello comparso all’inizio dell’estate sul sentiero che porta al monte Seceda, in Val Gardena.
Sospeso a metà tra il gesto dadaista, il grido di protesta e il tentativo di monetizzare, il tornello ha materializzato nel dibattito altoatesino il tema dell’overtourism.
A essere onesti, l’inglesismo circolava ormai da qualche tempo. Ma, complice l’attenzione mediatica, tra luglio e agosto la discussione pubblica sulle esternalità negative del turismo di massa si è infittita e, soprattutto, sembra essere diventata senso comune.
Fino a poco tempo fa, infatti, la narrazione mainstream vedeva nel turismo “il petrolio d’Italia”. Una risorsa dal potenziale economico enorme, benché sfruttata molto al di sotto delle sue reali possibilità.
O così almeno recitava la vulgata. Perché le (poche) voci critiche rispetto alla narrazione dominante venivano isolate e stigmatizzate. A nessuno era permesso mettere in dubbio le meravigliose e progressive sorti dell’industria turistica nazionale.
Quest’estate qualcosa è cambiato.
Non perché ci si sia accorti che il turismo è un’attività scarsamente innovativa, con un basso valore aggiunto e discutibili politiche in materia di diritti dei lavoratori.
A spostare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’overtourism è stato il carico antropico a cui sottopone i territori, in particolare quelli fragili e delicati come le Alpi.
Chiarisco: il carico antropico è un problema. Un grosso problema. Ma è solo uno dei sintomi dell’overtourism che, se affrontato esclusivamente da questo punto di vista, rischia di restare un fenomeno incompreso e, soprattutto, irrisolto.
Se l’obiettivo è elaborare modelli di fruizione del territorio davvero sostenibili, è importante capire quali sono i processi economici, sociali ed estetici che hanno plasmato quelli attuali.
La “condanna” della montagna-emoji, un editoriale di Fabio Gobbato pubblicato il primo agosto su Salto, evidenzia alcuni elementi chiave del dibatto; allo stesso tempo, mette in luce anche i “limiti” degli asset culturali con cui oggi si guarda all’overtourism e al suo impatto sullo spazio alpino.
Commentando il video di due content creator cinesi, Gobbato scrive:
ciò che accade in quelle immagini è più di un viaggio: è un rito mediatico. Una narrazione digitale perfettamente costruita in cui la montagna non è più luogo di avventura, di conquista, di riposo, non è un posto in cui l’essere umano cerca di ripristinare un contatto con la natura, ma è semplicemente sfondo per i propri selfie, una “quinta” tipo quelle di The Truman Show. È semplicemente lo specchio dei tempi: i social hanno modificato il nostro rapporto con la fruizione di qualunque tipo di esperienza. Documentare di esserci è a volte più importante che esserci.
Sul viaggio come rito mediatico, Gobbato ha ragione.
Con buona pace di chi è convinto che la possibilità di generare immagini con l’intelligenza artificiale abbia turbato per sempre la natura testimoniale dell’immagine, il selfie continua a marcare il ruolo dell’immagine come testimonianza dell’essersi trovati in un determinato luogo in un determinato momento.
La condivisione di immagini nelle reti sociali equivale a documentare il fatto di essere stati presenti nel qui e ora di un luogo.
O, meglio, di una destinazione. Perché il turismo contemporaneo non ragiona più in termini di luoghi, bensì di destinazioni. Aree che si raggiungono perché offrono la più ampia varietà di esperienze a quanti più microsegmenti di pubblico possibile. E, tra queste esperienze, centrale è quella in cui si attesta la propria presenza al cospetto dei landmark della destinazione stessa.
È centrale perché le Alpi sono un artefatto visivo.
Esse diventano rilevanti per la cultura europea, e dunque mondiale, intorno alla metà del Settecento, dopo che Ferdinand De Saussure sale per la prima volta sul Monte Bianco, dando inizio all’esplorazione dello spazio alpino e alla sua conseguente costruzione come oggetto culturale, di cui le arti visive sono sempre state uno dei principali strumenti.
Più o meno un secolo più tardi, nel 1852, il giornalista e impresario londinese Albert Smith mette in scena The Mont Blanc Ascent, uno spettacolo teatrale ispirato all’ascensione della vetta più alta delle Alpi, che Smith aveva compito l’anno precedente.
Il sapiente uso della dimensione visiva attorno a cui aveva costruito la sua messa in scena valsero allo spettacolo di Smith un incredibile successo.
La pièce rimase in cartellone all’Egyptian Hall di Londra per ben sei anni, generando una serie di spin off, tra cui un trattato storico sul Bianco in tre volumi.
Tra il 1852 e il 1858, The Mont Blanc Ascent venne replicato circa duemila volte, attirando in totale ottocentomila spettatori. Negli anni che rimase in cartellone, l’Inghilterra fu colta da una passione per la montagna così intensa da meritarsi l’appellativo di Mont Blanc Mania.
Quella che fino a pochi anni prima era solo una remota e spaventosa vetta alpina divenne rapidamente una delle mete più ambite da parte della borghesia inglese.
L’attenzione fu tale che il giornalista del Times incaricato di raccontare la moda ai suoi lettori arrivò a chieder loro, tra il serio e il faceto, di smettere d’inviare al giornale resoconti d’ascensioni. La salita alle vette alpine aveva perso a tal punto la sua dimensione eroica ed esclusiva da essere diventata un cliché diffuso e inflazionato.
Questo episodio mostra come la relazione tra immagini e spazio alpino sia tutt’altro che “lo specchio dei tempi”, bensì un fenomeno molto più antico e strettamente legato all’esistenza stessa delle Alpi.
A cambiare oggi sono soprattutto due fattori: la rapidità con cui circolano le immagini, questa sì un effetto dei social, e gli immaginari di riferimento delle persone.
Nel caso del Seceda l’esperanto visivo delle emoji sostituisce la pittura o la letteratura come repertorio di riferimento.
La dinamica per cui le Alpi vengono visitate per documentare la propria presenza attraverso la produzione di un’immagine che ne duplica una “originale” però non cambia.
Proprio come non cambiava quando la borghesia dell’impero britannico si precipitava a scalare il Monte Bianco solo per poter documentare la propria esperienza in decine, centinaia di resoconti tutti uguali.
Se pensiamo a come è stata costruita la fama del lago di Braies, un’altra delle destinazioni più celebri e massificate dell’Alto Adige, è impossibile ignorare il ruolo della fiction RAI Un passo dal cielo, che proprio nell’alta Val Pusteria vede ambientate le sue prime tre stagioni.
Un’operazione simile, ma di minor successo, è stata tentata anche intorno a Curon, in Val Venosta. Qui è stata ambientata l’omonima serie prodotta Netflix che metteva al centro del suo apparato visivo un’altra celebre immagine dell’Alto Adige: il campanile del paese sommerso nel 1950 in seguito alla costruzione della diga che ha formato l’attuale lago di Resia.
Non è un caso che la film commission dell’Alto Adige operi sotto l’egida di IDM. L’azienda di marketing territoriale di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano è infatti responsabile dello sviluppo del marchio “Alto Adige” e tra le sue unità di business ne ha una dedicata allo “sviluppo turistico dell’Alto Adige destinato a durare nel tempo”.
Dunque, quello che oggi Kompatscher stigmatizza come “turismo del selfie” non è solo un meccanismo legato alla natura dello spazio alpino come oggetto culturale portata al suo massimo grado di accumulazione dalle piattaforme, ma è anche il risultato di politiche precise che la Provincia Autonoma di Bolzano, e la SVP che l’ha governata e la continua a governare, ha portato avanti attraverso il lavoro di IDM.
In questa dinamica è possibile leggere i segni della mutazione che ha portato la SVP a trasformarsi da partito di massa di stampo novecentesco a un’entità tecnocratica.
Come tale, il suo compito è quello di recepire e applicare i dispositivi egemonici di governo delle persone e dei territori.
È proprio la natura tecnocratica del partito che permette a Kompatscher di scaricare la responsabilità della situazione sulle piattaforme e, allo stesso tempo, di cominciare a delineare il prossimo dispositivo di governo.
Un dispositivo fatto di “registrazione via app, prenotazione del parcheggio, presenze contingentate e a numero chiuso, accesso a pagamento” che avrà come conseguenza quella di creare nuove enclosures, sottraendo agli altoatesini il proprio territorio senza intaccare minimamente gli interessi del settore turistico, aumentandone invece le opportunità di monetizzare la presenza di massa.
Dopo tutto i turisti sono felici di poter vedere la montagna emoji anche se la funivia costa tanto, come dice un turista di Taiwan in un’intervista raccolta dalla trasmissione RAI Tagesschau e citata da Gobbato nel suo editoriale.
Se queste sono le premesse, quella intorno all’overtourism si preannuncia come una delle questioni politiche più rilevanti del prossimo decennio.
Una battaglia in cui la destra locale di lingua tedesca si sta già posizionando in modo efficace, mentre la sinistra sembra continuare a soffrire della sindrome di Cassandra.
Profetica nell’intercettare le tendenze economiche, politiche e sociali più rilevanti del tempo ma incapace di trovare una forma di organizzazione dell’agire politico in grado di permetterle di incidere sulle loro traiettorie.
🌪️ Che cos'è la turbolenza?
La turbolenza è il diario di lavoro di un libro su come la cultura globale si riflette nella politica altoatesina. Un modo per pensare in pubblico e condividere con te leggi gli appunti che prendo durante la strada.
Leggi anche le altre puntate della serie.💃 Il velo è il mio primo romanzo. È uscito nel 2023 per le edizioni alphabeta. Lo trovi in libreria e in tutti gli store digitali. Vuoi saperne di più?
☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️
Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.
Offrimi un caffè!