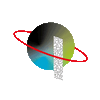Note sulla creazione di mondi.
Alcune cose che ho imparato progettando un workshop di worldbuilding.

L’atto di fondazione di uno dei più fecondi universi narrativi ha a che fare con il tempo.
Long time ago in a galaxy far far away. Sono le parole che aprono A new hope, il film che dà vita al mondo di Star Wars.
Leggendole, fin dai primi secondi della saga, lo spettatore diventa consapevole che la storia che sta per vedere è ambientata nel passato; anche se non sa bene perché, quel mondo esiste da prima di lui, in qualche modo lo precede.
C’è un’altra cosa di cui lo spettatore del film è immediatamente consapevole.
La storia che sta per vedere è già iniziata in un altro momento e in un luogo diverso dell’universo che sta per spalancarsi davanti ai suoi occhi. A new hope, il primo film di Star Wars è numerato come quarto episodio.
Quarto episodio di cosa?
Probabilmente di una saga. Non possiamo saperlo con certezza, lo possiamo solo intuire, solo immaginare, perché a parte quella dicitura non abbiamo altri elementi per corroborare la nostra ipotesi.
E i primi tre episodi? Esistono o si tratta solo di un raggiro che il regista ordisce ai nostri danni? Anche qui, non lo sappiamo. Possiamo solo intuire, solo immaginare.
Un mondo è la sua cronologia.
La lezione che apprendiamo qui è una: alla base di ogni universo narrativo c’è una cronologia.
Non me ne voglia Umberto Eco, per il quale la costruzione di un mondo era la costruzione di “universi completamente ammobiliati”, ma la creazione di una linea del tempo è più importante dell’interior design narrativo.
Non che questo sia inutile, tutt’altro, solo che è secondario rispetto alla creazione di cronologie.
Le cronologie sono le fondamenta di un universo narrativo. Sono la sua struttura. Sono l’architrave che ne regge il peso, l’espediente che dà loro profondità e ce li fa percepire come qualcosa di vivo e di cui possiamo entrare a far parte.
Quando adatta per il grande schermo Il signore degli anelli, anche Peter Jackson, come George Lucas prima di lui, inizia a costruire il suo universo delineando una cronologia.
La storia a cui stiamo per assistere, quella della compagnia incaricata di accompagnare colui che porta l’anello del potere per distruggerlo, è solo l’atto finale di una vicenda iniziata molto tempo prima, in un epoca di eventi di fronte alla cui grandezza quelli raccontati nel film impallidirebbero.
Questa differenza di scala, la magnitudo incommensurabile degli eventi, è una delle più riuscite intuizioni di Tolkien.
Il male che si scatena nei tre libri de Il signore degli anelli è solo l’ombra del male che ha squassato la Terra di Mezzo nel passato.
Ciononostante, il potere di Sauron è annichilente, distruttivo e il lettore, consapevole della cronologia dell’universo, può solo tremare d’orrore al pensiero di ciò che è stato prima e sentirsi sollevato dal fatto di non doverlo affrontare.
Ancora una volta è una cronologia che fonda e dona profondità a un universo narrativo.
Come si crea una cronologia?
Possiamo trovare una risposta a questa domanda nelle meccaniche di Microscope, un gioco di ruolo narrativo creato da Ben Robbins.
Prima di giocarci me lo avevano presentato come ”il gioco in cui si costruisce la Storia”. Dopo averci giocato ho pensato che fosse più “il gioco in cui si creano le linee del tempo”.
In Microscope le cronologie sono scomposte in tre elementi:
- i periodi, lunghi intervalli di tempo che possono corrispondere a un’epoca;
- gli eventi, accadimenti puntuali e localizzati all’interno di un periodo;
- le scene, avvenimenti che accadono all’intero di un evento e contribuiscono a illuminarne i punti oscuri.
Tale meccanica conferisce al gioco la sua natura frattale e crea le condizioni per cui una partita a Microscope può potenzialmente durare all’infinito, sfruttando la natura divisibile della linea come figura geometrica.
Questa natura fa sì che più il gioco va avanti e più è dettagliato il mondo che emerge dalla linea del tempo creata collettivamente dai giocatori.
È per questa caratteristica che ho messo le meccaniche di Microscope al centro della costruzione del workshop di worldbuilding che a cui ho iniziato a lavorare lo scorso anno.
Microscope mi permette infatti di facilitare alle persone che partecipano al workshop la simulazione e l’esplorazione di un mondo immaginario.
L’aspetto di questi mondi oscilla tra il verosimile e il fantastico a seconda di come ne viene gestita la creazione.
Durante la prima prova del workshop, per esempio, il mondo di gioco era il nostro mondo e l’ambientazione un futuro spostato avanti di vent’anni rispetto al presente.
O meglio, in quel caso i futuri erano tre, ognuno dei quali delineato a partire da uno scenario che avevo creato basandomi su altrettante previsioni a un potenziale sviluppo delle Alpi, espresse in un articolo Werner Bätzing, il più importante esperto mondiale di questo territorio.
Come si creano i mondi?
A partire da quella prima esperienza ho sviluppato il format e introdotto una seconda meccanica, ricavata anch’essa da un gioco progettato da Ben Robbins: In This World.
Scopo del gioco è la creazione collettiva di mondi immaginari.
Per crearli i giocatori partono da un argomento ben definito: il matrimonio, il turismo, la religione, le forze dell’ordine o qualsiasi altro topic di questo genere.
Dopo averlo scelto ne vengono individuati una serie di elementi, da cinque a sette. Partendo da questi elementi i giocatori creano una lista di dichiarazioni, da dieci a dodici, che descrivono in modo non controverso il modo in cui l’argomento di partenza funziona nel mondo in cui viviamo.
A quel punto, uno dei giocatori, che si propone volontario, sceglie una di queste dichiarazioni e descrive in che modo essa è differente nel mondo immaginario che si sta andando a creare.
In seguito sceglie altre due dichiarazioni che, al contrario, restano identiche.
Segue una fase in cui gli altri giocatori sono liberi di fare lo stesso e, in più, di aggiungere un dettaglio a tutte le dichiarazioni già scelte per creare il mondo alternativo.
Successivamente ogni giocatore può aggiungere un dettaglio e, alla fine, il primo giocatore descrive l’estetica del mondo e, collettivamente, gli si trova un nome.
Attraverso queste meccaniche il processo di worldbuilding avviene introducendo piccole distorsioni nel modo in cui funziona il nostro mondo.
Di distorsione in distorsione, dal mondo attuale ne viene generato uno che è simile e allo stesso tempo diverso da quello di partenza, come nel processo di divisione cellulare per meiosi.
Come funzionano i miei workshop di worldbuilding e simulazione sociale.
Ho sperimentato perlaprima volta l’integrazione delle meccaniche di In this world e Microscope durante una versione beta di quello che è diventato il workshop di worldbuilding e simulazione sociale che ho facilitato durante Common Ground.
Il risultato è stato sorprendente.
Lo è stato perché ho fatto lavorare i partecipanti al retreat - circa 40 persone - in tre differenti gruppi, definendo a priori i temi da cui partire per creare i mondo virtuali.
I risultati ottenuti sono stati a tal punto coerenti da permettermi di integrare i tre diversi mondi creati, trattandoli come se fossero un unico mondo.
Questo mi ha permesso ambientare al suo interno un’unico scenario narrativo che ha funzionato come cornice per la parte del workshop in cui ho accompagnato i partecipanti a simulare ed esplorare il mondo.
In questa fase sono riuscito a usare i tre mondi creati come altrettanti periodi all’interno della linea del tempo che ha fatto da base alla simulazione e all’esplorazione del mondo, condotte attraverso le meccaniche di Microscope.
Anche in questo caso, la cronologia è stata creata spostando l’ambientazione avanti di vent’anni rispetto al presente.
In questo modo il mondo virtuale creato collettivamente diventa una variante probabile del nostro mondo ambientata nel futuro.
Invitati a immaginare se stessi al suo interno grazie ad alcune meccaniche ricavate dal lavoro di Jane Mc Gonigal, i partecipanti vivono così un’esperienza di simulazione di scenari futuri, muovendosi lungo le loro cronologie per tornare indietro verso il presente o proiettandosi ancora più avanti nel futuro stesso sella simulazione.
A differenza di altri approcci alla futurologia, su cui Silvio Lorusso ha scritto una critica stimolante, il modo in cui ho integrato queste meccaniche permette ai partecipanti di sviluppare una visione retrospettiva più che una proiettiva.
A essere importante qui non è tanto, o non solo, la capacità di immaginare come si svilupperà una tendenza quanto, piuttosto, capire come poter arrivare a costruire un mondo virtuale (se il mondo tende all’utopia) o come sopravvivere al suo interno (se il mondo tende alla distopia).
Ruolo del curatore.
Il workshop di cui ho descritto rapidamente il funzionamento utilizza meccaniche pensate per il gioco libero, che possono essere utilizzate per creare mondi di qualsiasi tipo.
Per renderlo “significativo” rispetto alla realtà materiale è necessario introdurre un’istanza curatoriale che guidi l’attività.
Questa istanza si esprime in due modi: scegliendo a priori i temi da cui i partecipanti partono per creare i loro mondo virtuale e selezionando dati e informazioni utili a fornire loro le informazioni e il contesto necessari per ancorare l’attività alle tensioni del presente.
I mondi virtuali creati in questo modo mantengono così sempre ampi tratti di verosimiglianza, per quanto siano impregnati degli immaginari futuribili di chi partecipa al workshop.
Conclusioni e takeaways del workshop.
Dopo quasi un anno di lavoro su questo workshop ho oggi più chiari sia il processo di progettazione ed esecuzione che i takeaways che i partecipanti possono portarsi a casa da un’esperienza come questa.
L’obiettivo da cui sono partito - liberare il tempo e lo spazio necessari per immaginare e simulare in modo libero soluzioni a problemi concreti - rimane, ma a esso si affianca un obiettivo secondario.
Le meccaniche che utilizzo nel workshop sono basate su tecniche di racconto collettivo in cui il potere narrativo del singolo partecipante deve essere costantemente ceduto e negoziato con gli altri partecipanti.
Il workshop diventa così anche un esercizio di mediazione delle proprie idee e delle proprie istanze che favorisce in singoli e gruppi di lavoro lo sviluppo di dinamiche collettive più efficaci e meno conflittuali.
Vorrei lavorare con te, come faccio?
Ogni progetto in cui mi impegno nasce chiacchierando, dal vivo o in call. Se vuoi fissare un appuntamento scrivimi un’email e troviamo insieme il momento migliore per farlo.
Scrivimi☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️
Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.
Offrimi un caffè!