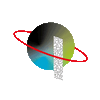Note su "Essere senza casa" di Gianluca Didino
Una breve recensione al saggio "Essere senza casa" di Gianluca Didino.

Le primavere arabe hanno rappresentato per i social media una sorta di passaggio all'età adulta. Sono state infatti il primo evento di rilevanza storica a essere non solo trasmesso ma anche (co)generato dai social media. O, quantomeno, il primo evento storico in cui i social media si sono ritagliati un ruolo di rilievo come principale mezzo di comunicazione e strumento organizzativo per le persone che a quegli eventi stavano prendendo parte.
Fu nel gorgo di quegli accadimenti che emerse in modo cristallino la natura dei social come dispositivo per l'autonarrazione di massa in tempo reale.
Nella racconto di quei giorni, i social venivano fatti apparire come la lente attraverso cui osservare la storia dispiegarsi davanti ai propri occhi in tempo reale. Ricordo però con grande chiarezza quanto fosse difficile dare seguito a questa affermazione.
La mole di contenuto prodotta in un singolo istante e la velocità con cui si susseguivano gli aggiornamenti degli hashtag di tendenza rendeva nebulosa l'esperienza di provare a dare un senso a quello che stava accadendo. Osservare le mie timeline mi dava, nei momenti di massima tensione di quel periodo, la stessa sensazione di star osservando il mondo filtrato dal muro d'acqua di un temporale violentissimo.
Non credo sia un caso se fu proprio in quei mesi che, per indicare l'attività di selezione, verifica e e cura dei contenuti pubblicati sui social, si prese a utilizzare l'espressione content curation.
Anche se potrei sbagliarmi, credo infatti che essa sia stata utilizzata per la prima volta per descrivere la pionieristica copertura delle primavere arabe fatta attraverso i social dal giornalista Andy Carvin che, grazie alla sua capacità di recuperare, verificare e contestualizzare la grande mole di informazioni prodotta grazie a tali media, riusciva a ritagliarsi quel ruolo di testimone a distanza degli eventi, che io non ero ancora abbastanza skillato per ricoprire.
Di curatela dei contenuti non si parlava però solo in relazione all'attività giornalistica. La capacità di aggregare e ridistribuire contenuti prodotti in rete dando loro un senso appariva una risorsa anche per i marchi e le aziende e la capacità di curare flussi di contenuti veniva a costituirsi come una risorsa a disposizione di chi usava i social media come uno strumento di marketing.
E anche se oggi l'uso di questa espressione sembra essere meno rilevante che allora, l'idea di curatela dei contenuti continua a sopravvivere, per esempio nelle numerosissime newsletter che, a cadenza più o meno regolare, selezionano e organizzano per i loro lettori contenuti disponibili in rete.
Mettendo a disposizione del consumatore d'informazioni tutti gli strumenti necessari per permettergli di produrre e distribuire informazioni a sua volta, il web 2.0 aveva dato vita a un diluvio di contenuto, all'interno del quale il content curator si comportava come la luce guida di un faro, che illuminava la buriana e indicava la rotta verso il porto sicuro del senso.
Se ho scelto di rievocare la memoria di questi eventi di un decennio ormai passato è perché nel concetto di curatela dei contenuti digitale ho trovato una pratica chiave di lettura per la struttura di Essere senza casa, il saggio che Gianluca Didino ha dedicato all'ipermodernità, ovvero la condizione di vivere in tempi, i nostri, in cui accadono cose "strane" (weird e eerie) e inaspettate al posto della costante ripetizione variata dei tropi della cultura popolare del passato che aveva caratterizzato la condizione postmoderna caratteristica del periodo della "fine della Storia". Una stranezza che, è la tesi alla base del lavoro di Didino, ha a che fare col tramonto (o il collasso) dell'idea di casa così come essa era stata costruita nella nostra cultura di riferimento.
Non credo sia sminuente definire quello di Didino un "saggio curatoriale" in cui la tesi di fondo viene espressa per intero fin dalla prime pagine e poi argomentata lungo tutta la durata del testo attraverso una rete di riferimenti che finisce per far assomigliare il libro a un lungo catalogo di dischi, libri, film e serie tv in cui la relazione tra la perdita della casa e l'incontro con una dimensione "strana" costituisce il tema portante della narrazione.
Una dimensione, quella indagata da Didino in Essere senza casa, che si nutre della specificità digitale della nostra epoca, così come la struttura del libro stesso sembra ricalcare la necessità curatoriale di muoversi sulla superficie della rete per connetterne insieme singoli frammenti, in grado di costruire un percorso coerente che è sempre l'espressione di uno sguardo personale sulla realtà che ci circonda.
Ed è nelle modalità con cui Didino articola il proprio sguardo che risiede l'aspetto che trovo meno convincente del suo lavoro, che pure resta uno stimolante catalogo di letture tenuto insieme da una tesi affascinante e produttiva.
La natura necessariamente personale e autobiografica del gesto curatoriale sembra infatti venir spesso mascherata da una pretesa di oggettività che porta l'autore, in alcuni passaggi, a elevare la propria esperienza personale a unità di misura di un'intero orizzonte culturale e generazionale.
Per esempio nelle prime righe del libro, in cui Didino scrive:
Certamente la mia generazione stava lasciando che strane cose "venissero a fare visita e rimanessero nei paraggi": dovevamo sapere che c'era qualcosa di strano nel fatto che la maggioranza dei nostri idoli era morta da decenni prima, la nostra musica preferita sembrava un'estensione delle colonne sonore dei film western e noir all'italiana degli anni Settanta e le ragazze di cui ci innamoravamo erano tutte repliche di Anna Karina in Alphaville di Godard.
Eppure io, che pure di Didino sono quasi coetaneo, non mi ritrovo nella sua descrizione e sento tanto distanti quanto alieni praticamente tutte le coordinate che dominano il paesaggio culturale tratteggiato nel libro.
La ragione di questo spaesamento credo risieda nel fatto che - è lo stesso autore a notarlo verso la fine del libro, senza purtroppo sviluppare le conseguenze dell'intuizione, come farà nel successivo e bellissimo Brucia, memoria - nella cultura digitale in cui viviamo immersi, l'atto di posizionamento che produce la nostra autonarrazione è un atto che ci isola e differenzia, attraverso la produzione di uno sguardo sul e di un racconto del mondo che sono solo e soltanto personali, anche quando riescono, con la forza del magnetismo che sviluppano, ad aggregare introno a esso altre monadi, altre solitudini, altre storie autobiografiche.
La lezione che ne traggo, germogliando il pensiero dalla lieve critica che muovo a Didino su questo punto, è che nel mondo pienamente digitalizzato abbiamo finito per barattare la solitudine con l'essere soli, e questa è la condizione su cui non facciamo che continuare a riflettere e scrivere, persi nell'imperativo incessante alla produzione d'informazione che caratterizza la condizione contemporanea.