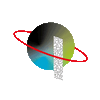Sbilanciare il minimalismo, costruire utopie
Ricordi, impressioni e una periodizzazione imprecisa dello stile estetico dominante dei primi anni del 2000.
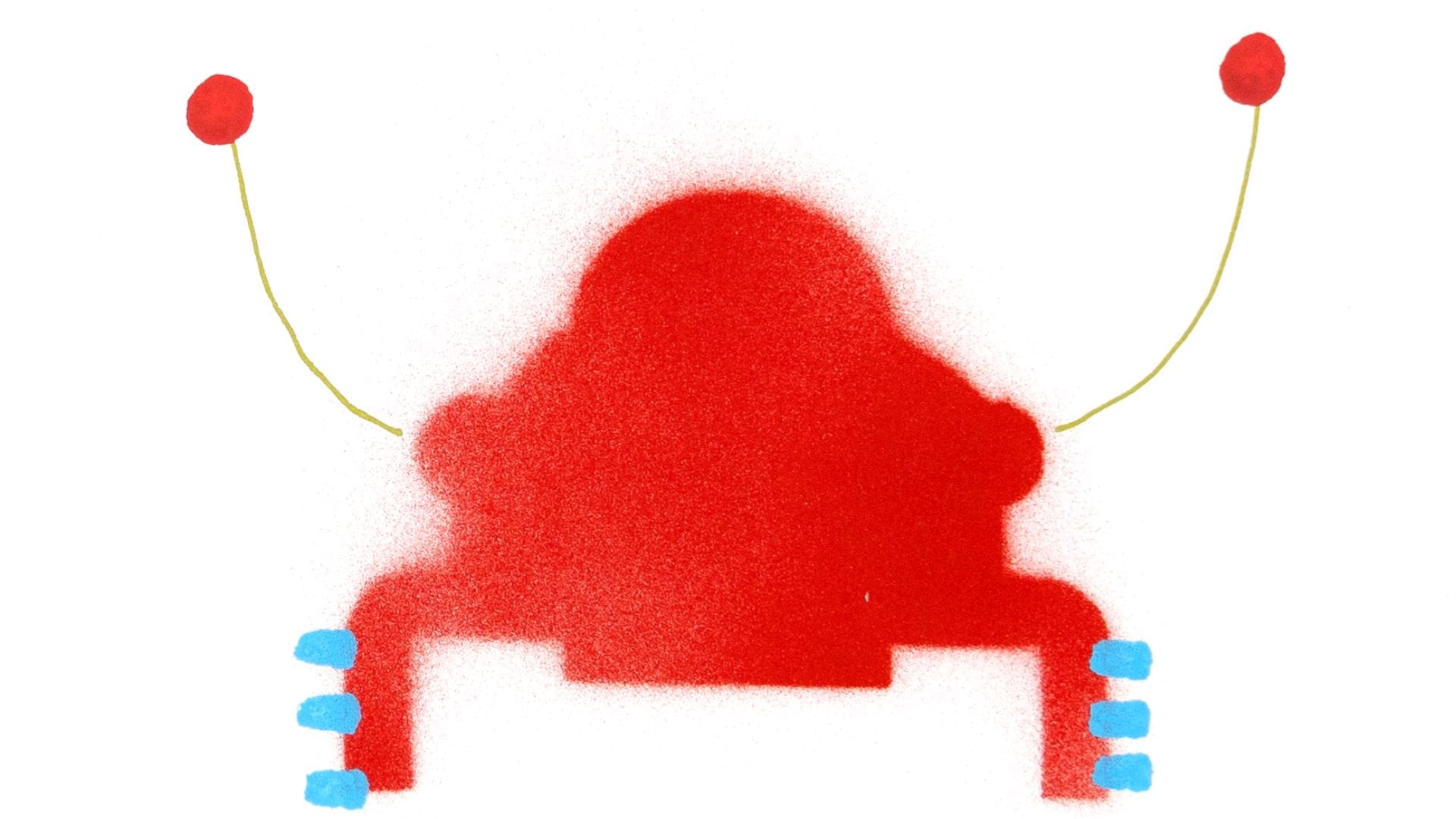
È imbarazzante iniziare un testo dedicato ad altri parlando di se stessi. Però sento di doverlo fare, il più brevemente possibile, per spiegare a chi legge la ragione di certe mie scelte che, più che scelte, sono necessità.
Il fatto è che sono uno scrittore, non un accademico. Buona parte del mio lavoro critico si basa su ricordi, sensazioni, elementi atmosferici che colgo o penso di cogliere nella realtà che mi circonda.
Se sul piano poetico costituisce un vantaggio, su quello del rigore il mio metodo costituisce un rischio.
Il rischio di periodizzare in modo approssimativo per esempio. Ovvero lo stesso rischio che correrò tra poche righe, quando inizierò a parlare di minimalismo come stile di vita.
Non so collocare nel tempo in modo esatto la prima volta che ne ho sentito parlare, ma ricordo perfettamente chi me ne ha parlato: il mio amico M.
Nel microcosmo della compagnia di cui ho fatto parte nei miei early 20s, M è stato uno dei primi utenti della rete, nonché un entusiasta della cultura digitale.
Non ricordo bene neppure dove e come me ne parlò, ma so per certo che era più o meno la fine degli anni zero del Duemila. La crisi dei mutui subprime si era già manifestata, definendo con la sua apparizione l’immaginario della prima amministrazione di Barack Obama.
Com’era accaduto dopo l’11 settembre, anche in quel periodo l’impressione era che il mondo come lo avevamo conosciuto stesse per finire. La capacità del modo di produzione capitalista di contribuire al benessere globale veniva scossa dagli eventi e messa in discussione dai suoi critici.
Il futuro che si apriva di fronte alle nuove generazioni non era più quello dominato dalla logica di guerra permanete in cui il mondo era stato precipitato dalla war on terror.
Era un mondo in cui il lavoro perdeva definitivamente i suoi attributi di stabilità per farsi del tutto fluido e aleatorio, mentre i cambiamenti climatici, pur iniziando a produrre regolarmente eventi catastrofici, apparivano ancora una dinamica reversibile.
Per continuare a legittimare la sua esistenza e le sue pretese di controllo anche di fronte a questo scenario, il Capitale raccontava alle persone della necessità di adattarsi per sopravvivere.
Il minimalismo di cui M mi tesseva le lodi predicava - a noi millennial e alle generazioni che stavano venendo dopo di noi - di sostituire l’accesso al possesso.
Dal momento che vivevamo in case sempre più piccole e costose per permetterci l'illusione di frequentare i luoghi necessari a competere su un mercato del lavoro sempre più spietato che senso aveva riempirsi di oggetti che, probabilmente, avremmo usato non più di una volta e, spesso, non avremmo usato mai?
Dopotutto avremmo potuto avere a disposizione tutta la produzione culturale umana, ovunque e quasi all’istante.
Era questa la sfida e la promessa che le grandi corporation del tech facevano al mondo, miniaturizzando e incorporando terminali nei più disparati oggetti della vita quotidiana mentre delocalizzavano negli angoli meno visibili delle periferie e delle campagne le banche dati necessarie a immagazzinare il sapere.
Le interfacce delle piattaforme dominavano il panorama visivo, mentre il touch&feel degli iPod, dei MacBook e, infine, degli iPhone contribuiva a definire l’esperienza estetica del presente.
Un orizzonte che trovò il suo corrispettivo politico nell’austerità che dominò la governance europea di quegli anni e finì in frantumi come la vetrina di un negozio di elettronica saccheggiato nella notte durante una delle tante esplosioni di rabbia popolare che illuminarono le notti dei primi anni dieci.
È ammirando i disegni e gli oggetti che Pietro Corraini ha realizzato per questa mostra e che sono riprodotti in questo catalogo che mi è ritornato in mente il clima di quei giorni e le tensioni estetiche e politiche che lo hanno attraversato.
Questo non tanto perché vi facciano riferimento in modo diretto ed esplicito quanto, piuttosto, perché è come se questi sgangherati assemblaggi composti da segni tecnologici ed eccedenze kitsch evocassero la possibilità di una fuga.
La fuga da una realtà lisca, levigata, piatta, funzionale, pacificata, priva di spigoli, performativa all’eccesso e contundente come una camera di contenzione.
Le opere qui raccolte ci parlano di un altrove, di un mondo altro che costruiscono, almeno come possibilità, come potenziale.
Un mondo in cui l’inutile, il superfluo e l’eccedente non possiedono soltanto un loro spazio, ma lo costituiscono e lo incarnano come ne fossero la massima espressione.
Un mondo sbilenco, in bilico come in bilico risulta chiunque provi a camminare in avanti, sbilanciando il proprio corpo di passo in passo e mettendolo a rischio per il solo gusto di vedere cosa può esserci un palmo più avanti del proprio naso.
Insomma, un mondo libero e casuale in cui mi piacerebbe poter vivere, almeno per un istante, per capire se è davvero così meno desiderabile di quello che ci troviamo ad abitare ogni giorno.

☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️
Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.
Offrimi un caffè!