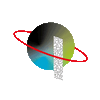"La carne delle cose" su Manaròt. Rivista di letteratura atesina
"La carne delle cose" è un racconto apparso nel gennaio del 2021 sul "Nachlass", il primo numero di "Manaròt. Rivista di letteratura atesina".

Il 15 gennaio 2022 è uscito Decay, il terzo numero di Manròt. Rivista di letteratura atesina. All'interno è presente un mio racconto, Sangue Acido. Decay è distribuito nelle librerie, il cui elenco è disponibile sul sito della rivista. Quello pubblicato di seguito è, invece, il racconto apparso nel gennaio del 2021 su Nachlass, il primo numero della rivista.
“Guarda” disse Marcello, mettendomi sotto gli occhi un’immaginetta che impiegai un attimo per mettere a fuoco. “C’è dentro tutta Bolzano”.
La stringo nel palmo e premo i polpastrelli contro gli spigoli. Cerco di ricreare la sensazione che ho provato, quella strana scarica di energia che ha pervaso il mio corpo la prima volta che l’ho toccata. Che ho toccato la calamita.
In primo piano, tre quarti dell’immagine era occupata da una veduta di piazza Walther, il salotto buono bolzanino. L’aiuola sotto alla statua di Walther von der Vogelweide - il Minnesänger che da queste parti chiamano “il Dante tedesco” - è un tappeto verde ribollente di fiori colorati. Figurette di persone in maniche di camicia passeggiano lì intorno o s’assiepano sotto ai gazebo dei bar, avvolte nella più banale e calda luce di tarda primavera. Dietro la statua, sulla destra, si scorgono i portici di quello che fu il palais Campofranco, sormontati dalla scritta Bolzano-Bozen in sovrimpressione. Sulla sinistra, il duomo col campanile tardo gotico e i tetti di maioliche verdi e dorate. L’immagine è stiracchiata, piegata ai lati, deformata come se fosse stata presa con un fish-eye. È incorniciata dal profilo delle pendici di due montagne che creano come una quinta dietro la quale si staglia la mole innevata di quello che, a prima vista, mi pare proprio essere il Catinaccio-Rosengarten. Ma sì, non può che essere altro che lui, il Catinaccio. Dopotutto, anche se l’immagine è tagliata malamente verso l’alto, quelle incastonate tra la statua del Vogelweide e il campanile della chiesa sono evidentemente le tre Torri: la principale, la nord e quella est.
“Lo so, lì non ci dovrebbero essere quelle montagne” m’anticipa Marcello, come se m’avesse seguito col pensiero mentre i miei occhi leggevano l’immagine, elaborandone il senso. Già, il Catinaccio-Rosengarten sta dalla parte opposta di quella veduta della piazza. Da quella posizione, al limite, ci si potrebbe scorgere in lontananza il profilo del monte Macaion, col suo riconoscibilissimo avvallamento squadrato. M’accorgo allora che l’immagine è una costruzione sintetica, una specie di fotomontaggio a tre dimensioni che serve a rappresentare la città, affastellandone in quello spazio microscopico alcuni degli elementi più riconoscibili. Un coagulo di porzioni di spazio-tempo collassate una sopra l’altra. A giudicare dalla fioritura, nella piazza sarà fine maggio, sulle montagne pieno inverno, tanto le pareti sono cariche di neve. Qualcosa nell’angolino in basso a sinistra mi pizzica l’occhio. Come ho fatto a non notarli prima? Sotto una nuvola violetta che dovrebbe essere il ramo sfocato d’un albero in fiore, ci sono due bambini. Camminano affiancati e stringono, uno con la sinistra e l’altra con la destra, un cesto di vimini colmo di fiori. L’immagine ha un che di nuziale. Lisci e biondi al limite del parossismo, distanti anni luce dal tipo del contadino affilato e spigoloso che Leni Riefenstahl racconta d’aver apprezzato in uno dei suoi soggiorni altoatesini, indossano gli abiti della domenica, quelli della messa o delle grandi occasioni. Lui camicia bianca e pantaloni neri, con un panciotto nero anch’esso da cui spunta una catena d’oro. Lei calze bianche, gonna blu, corpetto nero e rosso sopra una camicia bianca, con corte maniche a sbuffo. Sono alti tre volte le persone accanto a cui il perito grafico autore dell’immagine ha deciso di collocarli. Potrebbero, se volessero, schiacciare tutti i turisti scollacciati che passeggiano ignari di loro sul pavé. Gli basterebbe alzare un piedino, soltanto un piedino, calarlo, assecondare la gravità, per annullare quei corpi in villeggiatura.
Forse Bolzano è esattamente questo, un luogo in cui l’armonia nasconde il collasso, mentre su ogni cosa vigilia il matrimonio mistico della tradizione, la sola forza capace di tenere tutto questo insieme a dispetto delle prospettive aberranti con cui costringe lo spazio-tempo a piegarsi, ad appiattirsi. Time is a flat circle, mormora Reggie Ledoux, mentre la stanza intorno a me glitcha e, per un istante, sono anche io inginocchiato in una palude della Lousiana, minacciosa e derelitta come la mia città.
Poi tutto comincia a girare. I confini delle cose si rincorrono gli uni con gli altri in una centrifuga. Lo spazio accelera, rotea su sé stesso. Al centro di questo vortice che si schiude dalla rotondità del minuto cestino di fiori tenuto in mano da quei giganti bambini e si espande fino ad avvolgermi tutto, ecco che appare, nitido davanti agli occhi, un altro circolo. È un cerchio, brunito, liscio e freddo. È il tondo metallico dalla macroscopica corona di spine che per anni gli Schützen hanno portato con loro in manifestazione per simboleggiare le sofferenze patite dalla gente di questa terra. Dura un istante, quella visione; e mentre il lugubre scalpiccio di passi cadenzati si spegne, l’immagine s’allontana trascinata sul fondo della mia pupilla e subito sostituita. Tondeggiante, il grottesco volto batrace di una scultura di Kippenberger s’avanza dal fondo del vortice finché la rana, inchiodata alla croce, non emerge completamente dal frigo dominando la cucina con la sua presenza. Cala il buio, screziato soltanto dal gioco di luci e ombre che le fiaccole del vilipendio e le torce dell’indignazione gettano su Zuerst die Füße, così si chiama quell’effigie precipitata sulla nostra terra da un altrove blasfemo. Ma la ridda dello sdegno dura poco, giusto il tempo di dar soddisfazione agli imbecilli e lasciare, sul pavimento della sala, il residuo ammonticchiato della festa che una solerte donna delle pulizie già s’appresta a sgomberare con decisa autorità, spazzando via la sozzura con colpi di scopa circolari prima rapidi e poi via via più lenti e ampi.

Un respiro e sono di nuovo a casa, la faccia piantata davanti allo sportello, un rigagnolo di sudore freddo che scorre tra la base del collo e la spina dorsale. Stringo la calamita tra le mani e la faccio scivolare nella tasca dello zaino che mi sto caricando sulle spalle. Guardo fuori dalla finestra e vedo l’orto che fu di mia nonna prima e di mio padre poi. Lascio proseguire lo sguardo tra le case degli operai. Supero i tetti del blocco che chiude il quartiere e i miei occhi ora s’arrampicano sulle balze innevate della montagna di fronte. All’altezza del Castel Flavon vengono sospinti verso l’alto dalla verticalità delle pareti. La giornata sarà limpida e tersa, penso. Ieri notte s’è alzato il vento. Ma a me non resta più tempo per struggermi. Qualcosa mi chiama e devo andare. Abbasso l’avvolgibile ed esco. Bolzano, e con lei questa Provincia così apprensiva da essersi guadagnata l’appellativo di “mamma”, sono qualcosa da cui scappare, da cui affrancarsi, da cui emanciparsi. La fuga e l’assenza sono lo strumento per farlo. Perciò la fine del liceo, l’inizio dell’università - quella vita lontana, in un altrove qualsiasi, in un posto che fosse “dappertutto tranne qui” - hanno scavato un solco che mi separa dal mio luogo d’origine. Poco meno di dieci anni è durato quell’esilio volontario, che io e come me anche altri, amici o sconosciuti, avevamo promesso sarebbe stato per tutta la vita. Poi sono tornato - siamo tornati in molti a dire il vero, quasi tutti - portandomi dietro questo senso d’assenza a un luogo che in quei rari, cadenzati ritorni a casa che il calendario ci concedeva, mi sembrava rimanesse sempre uguale a sé stesso, immobile, immune allo scorrere del tempo. Lungo l’autostrada A22, i cartelloni che indicano le distanze dei caselli iniziano a riportare il nome di Bolzano più o meno all’altezza di Rovereto. Prima di allora, per la segnaletica autostradale, nei circa centocinquanta chilometri che separano Trento dal confine non sembra esserci nulla di notevole: un vuoto chiamato Alto Adige. È in questo vuoto che abitano i fantasmi della calamita. Che sono poi gli stessi che mi perseguitano quando, ovunque sono, dichiaro la mia provenienza.
Ma non mi pare che parli con l’accento di Bolzano. Quale accento? Quello vostro, tipo il nonno di Heidi. Ma io non sono tedesco. Ah, non siete tutti tedeschi dalle vostre parti? No.
Nel vuoto proliferano i cliché. Lo saturano senza riempirlo perché sono piatti, monodimensionali. Lo mascherano, ci si appiccicano sopra come una pellicola vischiosa su cui il tempo scivola via dissimulando il cambiamento. Anche io ci rimbalzo, su questa superficie elastica che ti separa dalla carne delle cose.
Penso a questo mentre aspetto il bus, camminando avanti e indietro sotto alla pensilina, le mani ben ficcate nelle tasche a proteggerle dal freddo di queste gelide sette del mattino. È allora che mi scappa uno sbuffo. Una donna mi cerca con sguardo complice. Guardò dall’altra parte. Ci s’aggrappa, “son sempre in ritardo, è vero o no?”. Abbozzo un ghigno tirato e provo a far finta di nulla: “nella direzione opposta ne son passati diversi da quando sono qui, nella nostra invece nessuno”. Arrivati a questo punto ho già messo mano al cellulare e avviato l’applicazione dell’azienda di trasporti, “ha solo cinque minuti di ritardo, vede” dico io con una punta di fastidio per nulla celato, mettendole lo schermo sotto il naso “ci sarà traffico, è l’ora di punta dopotutto. Vedrà che adesso arriva. Di solito sono abbastanza puntuali.”. Mentre la donna sta per ribattere che no, non è vero, che ieri l’altro ha aspettato per più di venti minuti e che l’autobus non arriva mai ecco spuntare il 110 da dietro la curva del cimitero, salvandomi sul filo di lana. Le porte s’aprono con il loro solito sibilo pneumatico. Mentre salgo penso che, fossi stato da solo, mi sarei spazientito anche io. Siamo a Bolzano, mica a Roma. Le cose, qui, funzionano.
M’accomodo al solito posto, ultima fila, sedile a destra. Scelgo quello perché proprio lì sotto è alloggiato il motore e dal rivestimento di plasticone che lo copre sgorga, piacevole, un certo calore dai sentori di gasolio. Il bus squarcia via Claudia Augusta, il cuore di Oltrisarco. Finché il sogno industriale italiano è durato questo era il quartiere degli operai che lavoravano negli stabilimenti siderurgici e automobilistici costruiti al di là della ferrovia che s’intravede ogni tanto oltre le fila di case sulla sinistra. Mio padre me li indicava, se capitava di passarci vicino con la macchina, e raccontava che quando facevano la fusione, di notte, negli anni Cinquanta, il quartiere s’illuminava dei riflessi rossastri degli altiforni e il giorno successivo tutti avevano un bel daffare a spazzare via la rena rossa che si depositava sui balconi. Solo che da quelli veniva via più facilmente che dai polmoni, come quelli devastati di mio nonno che per colpa della fabbrica non ho mai conosciuto. È morto che mio padre aveva otto anni e gli ha insegnato che non esiste un padrone buono, come canta Bresh in una sua canzone ricordandomi, ogni volta che la sento, che quel retaggio è anche il mio retaggio. Chiusi gli stabilimenti, a minare la salute degli abitanti del quartiere, oggi tra i più multietnici della città, ci hanno pensato i gas di scarico dell’autostrada che corre sopraelevata, parallela anch’essa alla via Claudia Augusta, ancora una manciata di chilometri più a sinistra della ferrovia. Nonostante tutto sono orgoglioso di aver vissuto nel quartiere fino a oggi. Oltrisarco, con le sue villette e palazzotti d’inizio novecento costruiti in un modesto stile liberty che s’alternano a caseggiati più moderni, ha in sé un fascino street che pochi altri quartieri della città possono vantare. A quindici anni avrei pagato per poter dire d’essere un Oltry Boy, perché quanto a credibilità di strada chi ci passa la vita, nel quartiere, non è secondo a nessuno. Crescere qui, sentii dire da un ragazzetto all’amico, un pomeriggio che tornavo dal lavoro, è come crescere a Napoli. Non proprio, penso, ma credo anche sia bello poter fingere di venire da un posto dove la vita non ti regala un cazzo, anche se vivi nella provincia più ricca d’Italia.
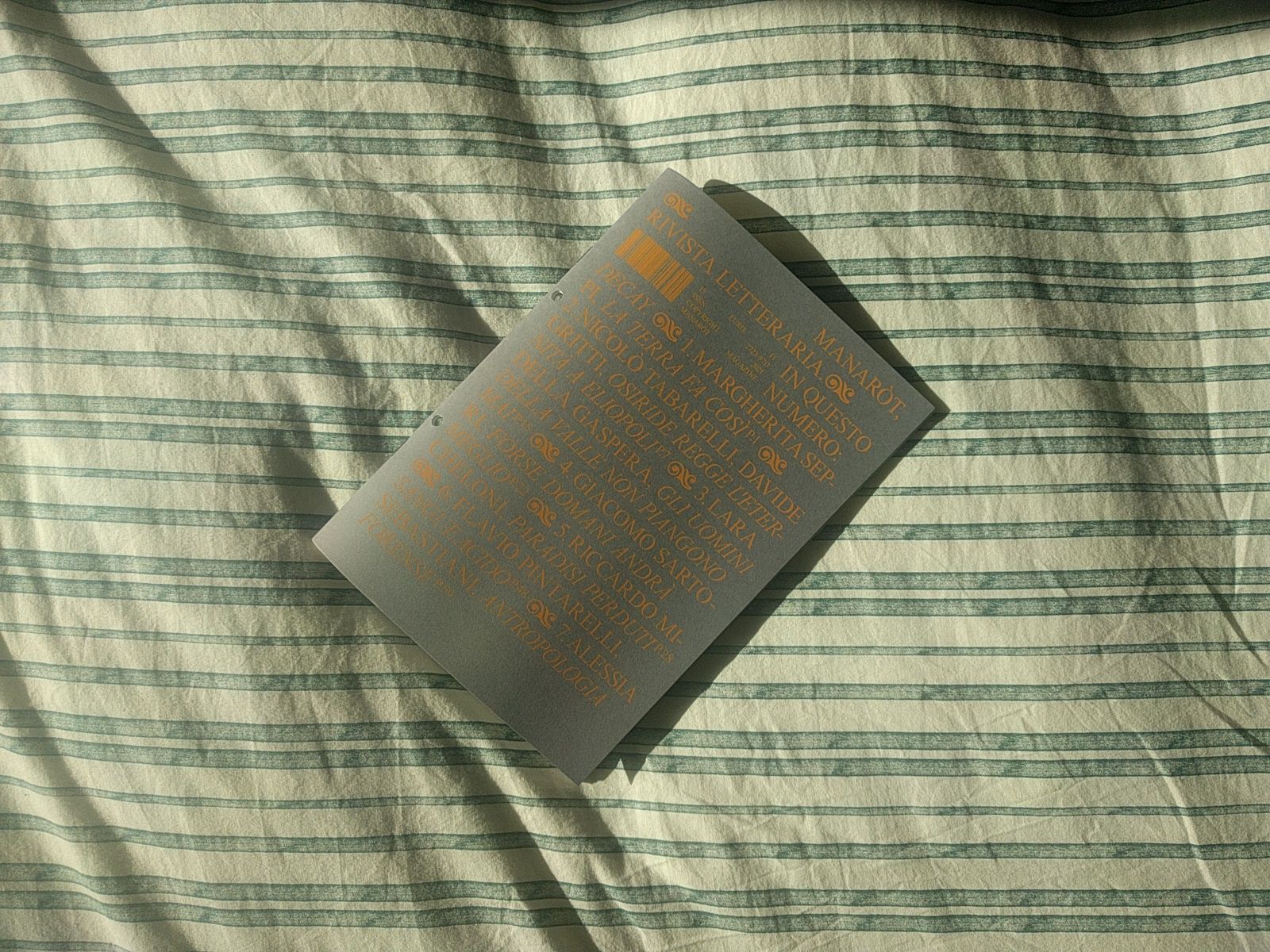
Superato il ponte, il percorso dell’autobus resta lineare per qualche chilometro ancora mentre dai finestrini scorrono come quinte i palazzi di via Roma e corso Italia. Se non fosse per la piazza del Tribunale, quella col fregio di Mussolini trasformato in un meme antifascista grazie a un’azzeccatissima citazione di Hannah Arendt che recita “nessuno ha il diritto di obbedire”, questa parte del percorso sarebbe alquanto insignificante. È per queste vie che nel 2011 Casa Pound ha marciato in difesa del fregio e di Bolzano italiana. Ed è in una di queste, quella intitolata al socialista interventista Cesare Battisti, che ha la sua sede. Il bus ci passa davanti proprio in questo momento, rallentando prima della fermata, giusto in tempo per poter osservare i cartelloni esposti sulla strada questa settimana. Martiri delle foibe, mutuo sociale e l’immancabile “basta feccia! [cit.]”. L’indirizzo comunque non l’hanno scelto a caso. Via Cesare Battisti è nel cuore della Bolzano fascista. Quella costruita dal Duce, quella che quando c’era lui si dormiva con la porta aperta, quella di cui il Monumento alla Vittoria è l’unità di misura ultima ed essenziale. Mentre il bus passa a fianco del colonnato sormontato da fasci littori osservo ancora una volta la scritta latina che, sul frontone, fa da cornice all’immagine della vittoria sagittaria che scaglia la sua freccia a nord, verso il nemico di sempre: “hic patriae fines siste signa hinc ceteros excoluimus lingua legibus artibus”.
Chi vuol capire perché qualcuno avesse tanto in uggia questa costruzione da aver provato più volte a farla saltare in aria col tritolo non dovrebbe far altro che provare a tradurre quelle parole: “qui abbiamo fissato i confini della patria, qui abbiamo colonizzato i barbari con la lingua, le leggi e le arti”. I barbari sono, manco a dirlo, le popolazioni locali di lingua tedesca. Ma a chi viene da fuori per respirare la nostra aria, pura di perfezione, tutto questo non sembra interessare.. “Siamo in Italia o no? L’italiano lo dovrebbero parlare, con tutti i soldi che gli diamo!”, dice la vox populi del turista mentre il bus rallenta alla fermata di piazza Domenicani. Da qui al centro storico è questione di una manciata di minuti a piedi. Basta risalire via Goethe e in breve, sulla destra, si apre il lungo cunicolo di via dei Portici. Questo decumano, che da secoli è la strada delle botteghe mi ricorda che Bolzano, fino a un centinaio di anni fa, non è mai stato un centro di potere politico. La sua posizione ne ha fatto una città di bottegai, nulla di più. Qui regnano schei e svanziche e nel palazzo mercantile c’è ancora un quadro che raffigura l’allegoria delle tasse. L’apice di questa sua atavica vocazione al commercio, Bolzano la raggiunge però nella piazza che sto costeggiando adesso. Piazza Walther! È qui che, dalla prima domenica d’avvento all’epifania, si celebra quella grande liturgia del consumo che è il Mercatino di Natale. Una tradizione inventata di sana pianta, ripresa dal Nord Europa, impacchettata e rivenduta a uso e consumo dei turisti che da un generico sud d’Italia - per l’altoatesino medio una qualsiasi regione posta al di sotto del confine della Provincia rappresentato dalle chiuse di Salorno e immancabilmente meno efficiente, ricca e pulita della nostra - rigurgitano fuori da pullman, treni e automobili private con il solo scopo di partecipare a questa gigantesca orgia collettiva fatta di luci e colori che accendono le vie della città, riscaldando l’aria frizzante di dicembre per la quale si spandono gli odori pungenti del vin brulè e di ogni altra specialità locale. Dai grassi canederli ai goulasch saporiti, agli strudel speziati, il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi, capace di regalare tutta la romantica magia dell’atmosfera natalizia che avete sempre desiderato. O qualsiasi altra formula analoga che si legge su quei prospetti turistici e siti web che io stesso ho contribuito ad alimentare quando lavoravo come redattore pubblicitario: un’immagine diabetica di gioia natalizia che anche i locali vivono con un misto di riverenza («dopotutto “ne giova l’economia della città”»), e odio profondo, (ché “quando c’è il Mercatino ci vuole un’ora per fare un chilometro e state a casa teste di cazzo”).
Soffio fuori dai polmoni con forza, mentre le porte dell’autobus mi scaricano davanti alla facciata austera della stazione. Salgo le scale sotto gli sguardi di rimprovero delle statue che rappresentano le virtù della produttività e del lavoro. Guardo verso il parco che fra qualche anno non esisterà più. Al suo posto qui ci sarà un centro commerciale. Ho fatto la scelta giusta, mi dico, mentre le porte a vetri si chiudono alle mie spalle e percorro il lucido salone della biglietteria e scendo le scale e imbocco il sottopassaggio per poi risalire all’ultimo binario. Salgo i gradini, uno dopo l’altro, e allora rallento perché il passo si fa meno stabile, meno sicuro. Il vento gelido che soffia dal Brennero si sfoga ora fuori dall’imbuto della valle dell’Isarco, spazzando l’areale ferroviario e incanalandosi lungo la scalinata finendo per tagliarmi la faccia. Quando emergo sulla banchina mi tiro il berretto sulle orecchie e lo sento scricchiolare acrilico contro i capelli, carichi di elettricità statica. Dal regionale mi sciamano contro, rapidissimi, i pendolari delle otto e trenta che marciano compatti verso scuole e uffici. Un istante e sono solo. Alzo gli occhi. Di fronte a me chiazze di neve tra le vigne della collina di Santa Maddalena e le coste del monte Tondo brillano, illuminate dal sole che, sulla destra, è appena spuntato oltre la cima del Colle. Poco più indietro, a chiudere come un fondale la valle, fiera nella luce del mattino, con le balze di bianco addobbate, la mole del Catinaccio mi osserva indifferente, riempiendomi gli occhi e il cuore. Un primo fischio richiama i miei propositi alla mente. Vattene, lasciati tutto alle spalle, dice la voce. Un secondo fischio, qualcosa s’inceppa. Ora o mai più, sali, ti sei già dimenticato il conflitto etnico e l’eredità di Langer e il primo posto nella classifica della qualità della vita e come siete fortunati voi e non mi pare che hai l’accento bolzanino quale? Quello tipo Heidi, non parlate così voialtri lassù? mi scorrono di nuovo nelle orecchie tutte le frasi fatte, i fantasmi che sto rifiutando, le etichette che m’hanno appiccicato addosso. Tutto volevo lasciarmi alle spalle. Al terzo fischio ho già deciso. Il treno comincia a macinare lentamente il suo ritmo sulla strada ferrata. Io sto scendendo i gradini per tornarmene a casa. Metto una mano nella tasca e ne estraggo la calamita. La guardo, la stringo, mi pungo le dita sui suoi spigoli aguzzi.