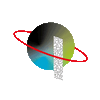Vivere senza autorevolezza
Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha determinato una perdita di autorevolezza dei tradizionali mediatori dell'informazione, producendo una reazione autoritaria. Come si può uscire da questo stallo?
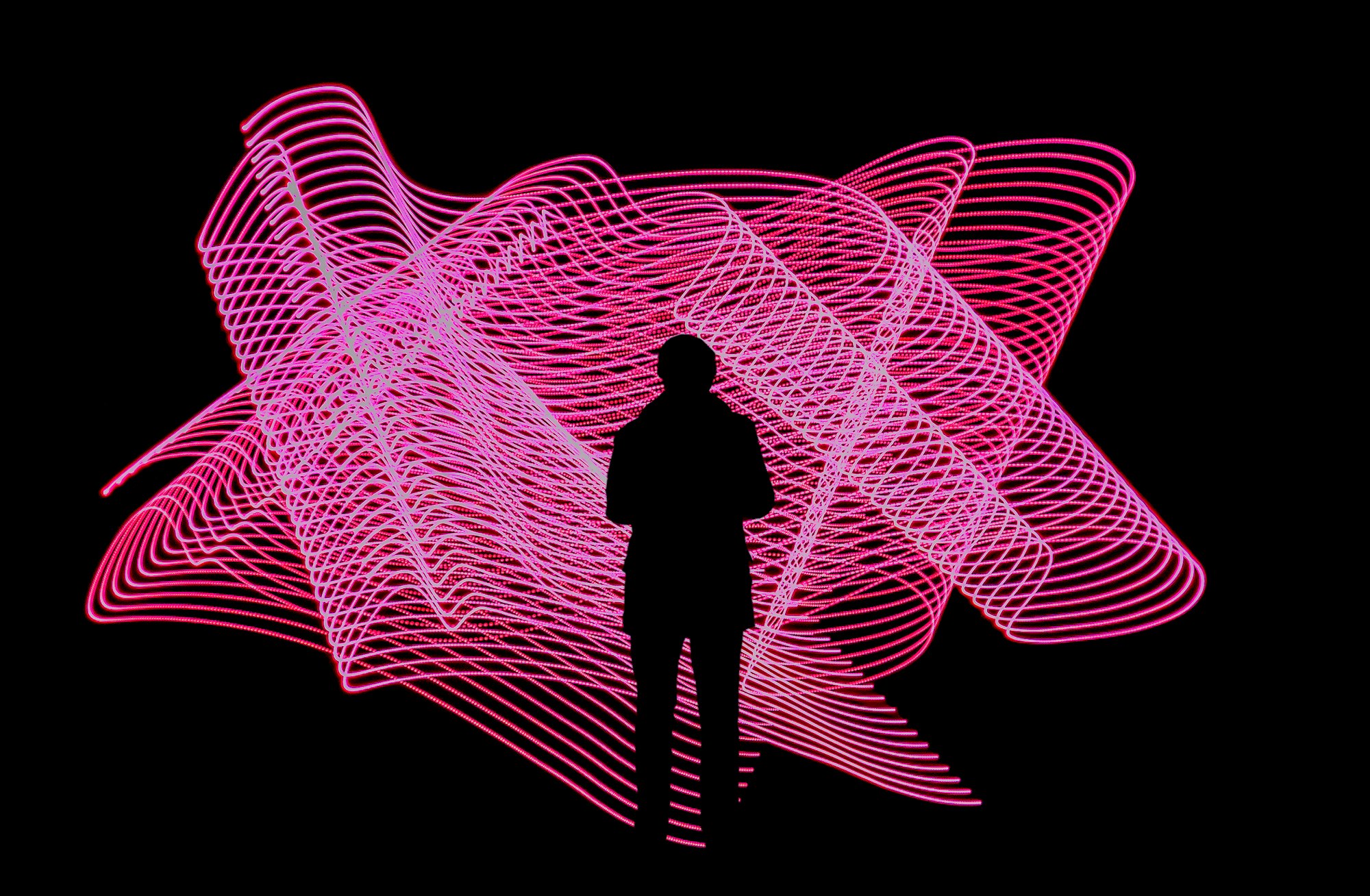
Qualche mese dopo essermi laureato, all’incirca una decina di anni fa, mi ritrovai a colloquio con il mio relatore in uno di quei localacci intorno alla stazione di Milano. All’epoca ero fermamente intenzionato a proseguire il mio percorso di studi con un dottorato e avevo raggiunto il capoluogo lombardo proprio per discutere questa eventualità con il docente che mi aveva accompagnato durante la tesi. Fu una chiacchierata piacevole, talmente piacevole che, dopo aver discusso una serie di tecnicalità legate alla mia volontà, finimmo per parlare dell’attualità culturale di allora. Sulle riviste e nei giornali teneva all’epoca banco il New Realism di Maurizio Ferraris nei cui confronti il mio professore, un semiologo di provata fede strutturalista, provava più di qualche riserva. Si chiedeva, infatti, come fosse stato possibile che alcuni concetti, da lui giudicati ormai acquisiti nel pensiero sulla natura di costrutto culturale delle nozioni di realismo e realtà, potessero essere rimessi in discussione e avere una tale fortuna critica e mediatica.
Mi alzai dal tavolo di quel bar tavola calda per tornare verso la stazione con dentro una sensazione di incompiutezza. Quella riflessione agrodolce mi aveva colpito e, durante il viaggio di ritorno, non riuscii a sedare la netta percezione che avrei avuto una risposta assai arguta da dare a quella preoccupazione; una di quelle frasi così pregne di significato da risultare risolutive nella loro brevità e chiarezza. Purtroppo non riuscii mai a formularla e quel pensiero rimase inespresso dentro di me fino a pochi mesi fa, quando ne ho ritrovato lo spirito in un passaggio di Trentacinque secondi ancora, il secondo romanzo dello scrittore romano Lorenzo Iervolino da poco pubblicato per 66th&2nd.
Il libro, per chi non ne avesse sentito parlare, racconta la vicenda di Tommie Smith e John Carlos, i due velocisti afroamericani che, nel 1968, espressero, col gesto del potere nero, solidarietà alle lotte per i diritti civili, dal podio dei 200 metri piani delle olimpiadi di Città del Messico. Verso la metà del volume c’è un capitolo in cui Iervolino si trova a intervistare il professor Harry Edwards, sociologo, attivista e ispiratore del Progetto Olimpico per i diritti umani, l’esperienza di militanza da cui nacque il gesto di Carlos e Smith. A un certo punto del capitolo Edwards pronuncia queste parole:
“Dopo anni di analisi e azioni politiche, ho capito un’altra cosa che per me è stata fondamentale. Mi chiedono spesso se sono scoraggiato dal fatto che nello sport americano, oggi, stiano di nuovo lottando per gli stessi motivi per cui mi sono battuto io, e con le stesse identiche modalità di allora. La mia risposta è: No. Ed è no perché le questioni contro cui ci siamo battuti e contro cui oggi si battono sono perpetue, sono dinamiche: ritornano. Questa lotta è ciclica e, sono ormai convinto, non può portare a vittorie definitive.”
Se potessi tornare indietro a quel pranzo milanese, al mio professore potrei dire queste stesse identiche parole, ché, come i diritti, probabilmente anche i concetti sono soggetti ai cicli storici e vanno di conseguenza rinegoziati ogni volta che se ne chiude uno e se ne apre un altro.
Il declino dell’autorevolezza
Della riflessione del professor Edwards sarà bene tenere conto da ora in avanti. E non soltanto perché, com’è ormai evidente più o meno a chiunque, le generazioni nate a cavallo del passaggio di millennio e quelle successive hanno attraversato e stanno attraversando un periodo di grandi e sostanziali cambiamenti di natura tecnologica, sociale e culturale; ma anche perché la stragrande maggioranza di questi cambiamenti è avvenuta e sta avvenendo sotto le insegne della disintermediazione e della disruption.
Con l’espressione disintermediazione, mutuata dal gergo bancario in cui è apparsa per le prima volta nel 1967, si indica generalmente la rimozione degli intermediari dalla catena di distribuzione di un prodotto. Mentre quando si parla di disruption, si fa di solito riferimento a una teoria dell’innovazione elaborata per la prima nel 1995, da Clayton M. Christensen e Joseph Bower, in un articolo pubblicato dalla Harvard Business Review e intitolato Disruptive Technologies: Catching the Wave e approfondita successivamente nel libro The Innovator’s Dilemma.
Secondo questa teoria le aziende strutturate, pur essendo perfettamente consapevoli e in grado di innovare, non avrebbero tuttavia la capacità di mettere a frutto i mercati più sensibili all’innovazione tecnologica. Questo perché, di solito, si tratta di piccoli segmenti, poco interessanti dal punto di vista di un’azienda che, per dimensioni e cultura, avrebbe uno scarso interesse a perseguirli. Un interesse che è invece fondamentale per le imprese start up che, al contrario, possono esplorare piccole nicchie di mercato per mettere alla prova i propri prodotti e modelli di business per poi scalarli verso bacini d’utenza più ampi.
Vista attraverso questa teoria, l’innovazione tecnologica non è soltanto la capacità di dare vita a prodotti capaci di incontrare bisogni e desideri latenti, ma anche quella di ridisegnare gli scenari di business intorno alle caratteristiche e alle esigenze del prodotto stesso, modificando di conseguenza gli ecosistemi economici e sociali in cui l’innovazione si produce e si sviluppa.
Sebbene questa teoria sia stata criticata, e da diversi punti di vista, l’idea di disruption è entrata a far parte stabilmente del nostro bagaglio concettuale e, insieme a quella di disintermediazione, costituisce uno dei nostri orizzonti culturali più stabili. La digitalizzazione dell’informazione, ad esempio, è un ambito in cui abbiamo assistito a entrambi i fenomeni. Si è avuta disintermediazione nella facilità con cui oggi possiamo produrre e, soprattutto, distribuire informazioni, un processo che ha avuto l’effetto di invertire il vettore di questa operazione, trasformando da verticale a orizzontale la dinamica con cui produciamo e distribuiamo informazione nel corpo sociale; dall’altra parte, ed è qui che si è verificata una disruption, ha creato e perseguito quel segmento di mercato rappresentato da tutti coloro che erano alla ricerca di un modo facile ed economicamente non impattante per creare e distribuire contenuti con cui esprimere la dimensione e le sfumature proprio “self”. L’apertura di questo mercato ha aumentato a dismisura il numero di voci (di nodi della rete) che producono e distribuiscono informazioni, creando un ecosistema dove la concorrenza per l’attenzione, una delle risorse più scarse in assoluto, è altissima e feroce.
Sono così apparsi, in questo scenario, una serie di linguaggi caratterizzati da una cifra estetica basata sull’immediatezza (dal selfie alla diretta video su You Tube, dalla geolocalizzazione ai live tweet) o, meglio, sulla costruzione di un effetto di immediatezza. I media digitali hanno così portato a compimento una tendenza che era già in atto nei mezzi di comunicazione tradizionali e attraversava trasversalmente l’universo della comunicazione contemporanea.
In questo contesto, i tradizionali soggetti deputati all’elaborazione e alla diffusione del sapere si sono trovati a dover negoziare il loro ruolo in un panorama radicalmente mutato, dove la produzione sovrabbondante di informazione, calata in un ambiente orizzontale im-mediato, ha dato la possibilità a singoli nodi della rete di acquisire un notevole potere di influenza (definiamo infatti influencer i più attivi tra questi nodi). A cambiare sono state soprattutto le logiche con cui si determina l’autorevolezza di una fonte; non a caso, in un articolo pubblicato su Prismo, Raffaele Alberto Ventura di riferisce a questo periodo come all’era del sospetto, un periodo storico nel quale il dubbio generalizzato è diventato uno degli orizzonti culturali di una società in cui la lentezza e l’impaccio con cui i tradizionali soggetti deputati alla produzione e alla distribuzione del sapere (università, musei, istituiti di ricerca, intellettuali, giornali, ecc.) hanno reagito a questo cambiamento, faticando tanto a comprenderne le logiche quanto i linguaggi, ha permesso che si erodesse la fiducia in quell’autorevolezza su cui si basava l’efficacia della loro azione.
Le forze che abitano il vuoto
Prima di degenerare in una dimensione spettacolare che ne ha obliterato ogni possibile efficacia, il dibattito sulla post verità, nato da una riflessione sul carattere post fattuale della nostra epoca, ha avuto il merito di porre l’attenzione sullo spostamento dalla natura testimoniale a quella misurabile del giudizio che esprimiamo sulla realtà. Anche se per un momento tutto sommato breve, si è accesa una luce sul vuoto prodottosi in seguito al declino del principio di autorevolezza. La domanda che dovremmo porci ora è la seguente, quali forze è possibile che si installino o si stiano installando in questo vuoto? E attraverso quali discorsi si esprimono?
Se guardiamo alle cronache di questi ultimi mesi - da Brexit a Trump passando, in Europa, per il peso crescente delle destre d’impostazione lepenista - sembra piuttosto chiaro come il populismo sia una delle forze, forse quella più chiaramente delineata, che stanno mettendo radici nel vuoto generato dalla disintermediazione del principio di autorevolezza. Come scrive Hamilton Santià su Il Tascabile,
populismo è una catch-all word, che fonda il suo successo sulla possibilità che in ogni momento della storia, a ogni livello, ci sia un popolo che si sente escluso e deprivato», ovvero un discorso che rilegge «il conflitto non più come “destra vs sinistra” ma “alto vs basso”.
È lungo quest’ultimo vettore che si genera quella diffidenza verso gli esperti che si tramuta facilmente in astio e caratterizza molte espressioni del discorso populista: dal rifiuto della politica al primato della percezione personale dei fenomeni sociali rispetto alla loro effettiva quantificazione, come accade puntualmente in relazione alle problematiche che riguardano la sicurezza.
Nel vuoto in cui ci stiamo muovendo, a questa dimensione emotiva e rabbiosa che si agglutina in un «corpo sociale nuovo, risultato della cosiddetta proletarizzazione del ceto medio» (è ancora Santià a notarlo), si contrappone un’altra forza, meno definita, che sembra nascere anch’essa dal declino e dalla scomparsa progressiva del ceto medio. Prendendo a prestito il titolo da un pezzo di Valerio Mattioli, si potrebbe chiamare questa forza “Orgoglio élite”, ovvero la rivendicazione, da parte della «classe creativa urbana e progressista» di una propria superiorità politica e intellettuale che viene rappresentata sotto assedio da parte di una minaccia a cui è necessario reagire prima che sia troppo tardi.
Il problema è che la natura di questa reazione, piuttosto che articolarsi intorno a un tentativo di ricostruire su basi nuove e adeguate ai tempi in cui viviamo il principio di autorevolezza, sembra risolversi spesso verso nuove forme di autoritarismo. Un esempio, tra i tanti possibili, è il crescente fastidio verso la democrazia come forma di organizzazione della vita politica, che è emerso più volte in occasione di eventi come Brexit, il referendum costituzionale o l’elezione di Trump.
Di fronte alla presa che queste argomentazioni, emotive e sostanzialmente prive di riscontri fattuali, fanno su quel corpo sociale escluso e deprivato che costituisce quel popolo a cui il discorso populista si rivolge, creandolo; questa autoproclamatasi elité ha preferito e preferisce vagheggiare dei futuri in cui i diritti politici sono vincolati a forme di valutazione come test o esami, piuttosto che ragionare sulla natura ideologica della democrazia e del discorso che la produce o per articolarne una critica, magari su basi libertarie; oppure immaginare percorsi di democratizzazione in grado di erodere il potere del capitale come suggerisce Erik Olin Wright.
Invece che usare il proprio capitale culturale per attivare processi di trasformazione dell’esistente, l’espressione dell’”orgoglio elité”, nell’ansia di contrapporsi all’irrazionalità dell’avversario, come è accaduto in occasione dell’approvazione del decreto sull’obbligo vaccinale, finisce per mimarne tanto le posture quanto i meccanismi retorici, in una reazione uguale e contraria che non solo appiattisce il dibattito in una dimensione da stadio ma, ed è ben più grave, contribuisce a far circolare nel dibattito ipotesi che fino a qualche tempo fa sarebbero state bollate come inaccettabili da chiunque si fosse auto rappresentato come appartenente al campo progressista: dall’esclusione della patria potestà alla pena di morte.
È come se questa “classe disagiata”, che si riconosce più nella propria formazione e nei propri consumi culturali che non nelle condizioni economiche che la caratterizzano, fosse talmente sbigottita dalla dissoluzione dell’orizzonte d’autorevolezza che è stata abituata a riconoscere da non essere capace di ripensarlo, ritirandosi in forme di autoritarismo che aprono scorci inquietanti sul futuro che ci aspetta.
In pochi sembrano accorgersi infatti che le uniche e vere elité sono proprio quelle forze che oggi sanno cavalcare il discorso populista e che hanno avuto in Berlusconi prima e in Donald Trump ora due autentici campioni. Se si raggiunge la consapevolezza di questa equivalenza, continuare ad alzare il livello di tolleranza del corpo sociale all’autoritarismo, con la scusa di condurre una battaglia campale contro un campo di forze che si vuole rappresentare come avverso, pur condividendo le stesse condizioni economiche di partenza, è una strada perdente che sembra avere come unico sbocco quello di dissodare il terreno migliore per far germogliare il lato oscuro di ogni discorso populista, che non può che essere il fascismo. Cosa fare dunque per scongiurare la distopia?
Come ricostruire l’autorevolezza?
La questione in ballo qui è, in effetti, assai semplice, e ruota intorno alla domanda: “come ricostruire un principio di autorevolezza?”. Stimolato direttamente sull’argomento durante la conferenza Connected Intelligence?, il massemdiologo Derrick DeKerckhove ha indicato nell’intelligenza artificiale lo strumento in cui riporre fiducia per ricostruire un principio di autorevolezza.
È un’ipotesi che spiazza, probabilmente perché le grandi narrazioni, da Terminator e Matrix, ci hanno abituato a una concezione distopica dell’intelligenza artificiale come elemento macchinico impegnato nella distruzione del o nell’estrazione costante di valore dal genere umano. L’utopia, come genere narrativo, è scomparsa dal nostro immaginario ormai da parecchio tempo. Eppure è proprio di un ritorno a essa, alla capacità di immaginare futuri alternativi rispetto a quelli che ci si prospettano, che sembra esserci davvero bisogno.
L’esortazione di DeKerckhove andrebbe perciò letta in questa direzione, come un invito a esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale come potenza liberante, come strumento in grado di garantire l’apertura di vie di fuga percorribili. Senza rinunciare a uno spirito critico che ci consenta di metterne in dubbio e interrogarne costantemente gli usi, forse dovremmo davvero prendere per buone le conclusioni a cui giungeva un saggio pubblicato qualche anno fa su Aeon, in cui Luciano Floridi si domandava se dovessimo davvero temere l’intelligenza artificiale, per rispondersi che no, non è necessario temerla bensì fare in modo che questa tecnologia ci aiuti a diventare più umani di quanto già non siamo.
Immaginare e raccontare in che modo sia possibile farlo è un compito che, per fortuna, le macchine non hanno ancora imparato a svolgere meglio di noi. È questa, credo, la missione più ambiziosa che ci aspetta di questi tempi.