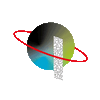La vertigine della nostalgia
L'obsolescenza programmata sta mettendo a rischio la memoria storica dei videogiochi. Ma sarà la nostalgia e la capacità di fare archivio a salvarci.

Se escludiamo le arti performative, non c’è forma d’espressione più volatile dei videogame. Questo perché i videogiochi sono completamente immersi nella logica neocapitalistica dell’obsolescenza programmata. Sono artefatti tecnologici destinati a essere ciclicamente dimenticati. A cadere nell’oblio ogni volta che il progresso partorisce una nuova generazione di hardware o software; e tanto più la tecnologia avanza, tanto più i cicli di sostituzione si fanno rapidi e ravvicinati. Talmente veloci da far sorgere il dubbio che i produttori, per salvaguardare i loro investimenti, siano oggi costretti ad allungare i cicli di obsolescenza programmata, piuttosto che accorciarli.
C’è stato un tempo, che è coinciso con l’infanzia del gaming domestico, in cui la progressione della tecnologia videoludica era scandita da un’enumerazione di potenza che aveva il bit come unità di misura. Otto, sedici, trentadue, sessantaquattro bit; fino a un certo punto la logica dell’obsolescenza si è espressa in questi termini, come se a parlare fosse un gruppo di ragazzini catturato in quella fase della giovinezza in cui le relazioni tra pari sono mediate unicamente dal confronto della performance: «tu sei veloce?», «quanto sei veloce?», «scommetto che sono più veloce di te».
Poi sono arrivate le console di nuova generazione - e anche se qualcuno è rimasto intrappolato nelle spire della sua infanzia, intestardendosi a combattere guerre il cui senso è ormai superato dalla Storia - alla maggior parte delle persone l’espressione numerica della potenza di un hardware per l’intrattenimento domestico ha smesso d’interessare.
Potevano davvero importarci ancora la potenza di calcolo di un processore o il numero di colori elaborabili su uno schermo, quando davanti a noi si aprivano mondi ed esperienze che fino a quel momento potevamo solo sognare?
È quest’accelerazione costante delle tecnologie di fruizione e produzione che rende i videogames così diversi dagli altri artefatti culturali. Se oggi possiamo leggere ancora un romanzo di Victor Hugo o godere la magnificenza di Nascita di una nazione di David Wark Griffith è perché libri e film, ma anche dischi e fotografie, possono essere trasferiti con una certa facilità da un formato all’altro. I videogiochi no.
I videogiochi sono software e questo significa che sono composti di codice, ovvero da una lista di istruzioni che devono essere lette e interpretate da una macchina per essere fruite. Mano a mano che la tecnologia avanza, gli standard mutano e vasti cataloghi di titoli diventano inservibili, perché l’hardware in circolazione non possiede più le specifiche necessarie per leggere il loro codice e interpretare correttamente le istruzioni in esso contenute. Per tutti questi titoli, il progresso tecnologico non significa altro che un inevitabile oblio. In assenza di un forte incentivo commerciale, infatti, i produttori di giochi non hanno alcun interesse a mantenere in vita il proprio catalogo di titoli.
Preferiscono lasciarselo alle spalle, quasi non fosse mai esistito, per concentrarsi sullo sviluppo di nuovi progetti.
È la maledizione del retrò di cui parla lo scrittore Simon Parkin in un pezzo uscito sul New Yorker nel gennaio di quest’anno. Una maledizione che minaccia di sprofondarci in un medioevo digitale in cui i nostri ricordi, in una riedizione videoludica del finale di Blade Runner, rischiano realmente di andare perduti come lacrime nella pioggia.
Ma è davvero così importante preservare quell’enorme quantità di titoli di cui l’evoluzione della potenza di calcolo dei nostri computer sembra aver decretato la damnatio memoriae? Di fronte alla complessità di giochi come Minecraft o all’emozionante spettacolo dei fenomeni atmosferici in GTA V che cos’hanno ancora da dirci le striminzite mappe di The Legend of Zelda a Link to the Past o l’umida nebbia delle caverne di Donkey Kong Country? Perché dovremmo voler giocare ancora con quei giochi immaturi, quando possiamo lanciarci verso l’infinito e oltre?
A dar retta al nostro spirito razionale verrebbe da rispondere che quei giochi rappresentano l’unico retaggio che ci lega alla storia del mezzo. In quei milioni di righe di codice ormai leggibili a stento c’è tutto quello che ha contribuito a definire ciò che i videogames sono oggi. Lì sono state precisate le meccaniche, lì si sono gettate le basi per l’elaborazione delle tecniche narrative, lì si sono sviluppati gli stilemi sonori e visivi. Perché anche se su quel corpus di giochi si proietta, inesorabile, l’ombra della dimenticanza, questi si comportano sempre come il foglio del rotolo del tempo descritto da Nietzsche.
Continuamente si staccano per rivòlare indietro, in grembo all’uomo, risvegliando in esso il fuoco del ricordo.
Il ricordo, in questo caso, non è soltanto ricordo di ciò che definisce il mezzo, ma diventa un momento intimo della nostra storia personale. Come qualsiasi altra forma espressiva o d’intrattenimento anche i videogiochi definiscono la nostra identità quando incrociamo con loro le nostre strade. Anzi, data la loro capacità di persistere, di presentarci sfide che ci chiedono dedizione e impegno totali, forse li investiamo di un ruolo anche più importante di quanto il loro posto nella gerarchia consolidata degli artefatti culturali tenderebbe a far credere.
Se oggi sono qui a scrivere queste righe forse è anche perché un giorno, alla festa di compleanno di un compagno delle scuole elementari, la mamma del mio amico, vedendomi così assorto davanti al minuto schermo di un GIG Tiger qualsiasi, profetizzò per me un futuro da “vero intellettuale”. Soltanto perché alle avventure in VHS di Fantaghirò, l’insopportabile eroina fantasy interpretata da Alessandra Martines, preferivo l’agitarsi frenetico di quelle figure in scala di grigi dalla limitatissima mobilità, ritagliate su sfondi colorati in cromie pastellate, i cui spasmi erano accompagnati da una colonna sonora di blippettii più o meno modulati. A raccontarlo oggi, questo episodio può risultare insignificante; ma a quel tempo rendermi conto che la dedizione che mettevo in qualcosa di così piccolo e tutto sommato primitivo come un GIG Tiger potesse avere la forza di trasformarmi in un intellettuale, una figura che fino a quel momento era appartenuta esclusivamente al regno degli adulti, ebbe su di me un’influenza enorme.
Essere un “vero intellettuale” significava innanzitutto diventare diverso dai miei compagni di scuola e allo stesso tempo preconizzava un futuro in cui l’azione di giocare ai videogiochi fosse qualcosa di più di un semplice svago a cui dedicarsi anche con un po’ di vergogna, vista la fama non proprio lusinghiera che accompagnava i videogame al tramonto degli anni ‘80.
A farci percepire come un pericolo la dimenticanza in cui rischiano di cadere un vasto numero di videogiochi vi è perciò qualcosa di più profondo e istintuale della sola consapevolezza di stare perdendo una parte costituitiva della storia della forma d’espressione e d’intrattenimento, che più di ogni altra sembra caratterizzare la nostra contemporaneità.
Questa forza, qualcosa che scava al di sotto della nostra razionalità e che attiva il nostro istinto di conservazione, è la nostalgia.
Ovvero la consapevolezza che ad andare perduti non sarebbero soltanto dei videogiochi, ma tutto quel grumo di memoria intima e personale che abbiamo sedimentato intorno a ogni singolo titolo. Così come in Citizen Kane Rosebud non è soltanto lo slittino che lega Charles Foster Kane all’infanzia, residuo suo ultimo di umanità, ma il motore invisibile che muove il racconto e l’esplorazione dei suoi passati, allo stesso modo l’essenza del retrogaming non risiede soltanto nel rivivere le singole esperienze di gioco, gravitanti intorno a un unico oggetto. Bensì si tratta di una ben più complessa reminiscenza del modo in cui quell’esperienza di gioco è diventata parte della nostra vita e a contribuito a dare forma alla nostra storia.
È un sentimento, la nostalgia, che permea la nostra cultura, ormai pienamente digitale, così a fondo da esserne diventata un tratto distintivo. Impregnati come siamo dall’immediatezza delle interazioni che avvengono in una rete che sempre più coincide con le piattaforme social, abbagliati dalla velocità con cui circola l’informazione, storditi dall’impressione che tutto prenda forma sotto i nostri occhi e tra le nostre mani, a volte sembriamo dimenticare che il sistema operativo della nostra epoca ha le fattezze dell’archivio.
Ciò che rende possibile l’immediatezza che caratterizza la nostra cultura è la sua complementare capacità di archiviazione. Così come il cinema si definisce all’incrocio tra ottica e chimica, il digitale emerge dall’incontro tra la capacità di elaborazione e la capacità di memorizzazione dei nostri computer e delle nostre reti; e la server farm diventa l’immagine più attuale di tutta la memoria del mondo.
Il desiderio di poter rivivere il passato - anzi, l’idealizzazione del passato che ci siamo costruiti nel corso della nostra vita - acquisisce oggi una forza senza precedenti e un vastissimo numero di forme. Ostalgia, vintage, retrò sono solo alcune tra le tante che la nostalgia può assumere.
È perciò agli sterminati archivi della rete che ci rivolgiamo per combattere quella “ipocondria del cuore” di cui ogni nostalgico accusa graffi e morsi.
In questa ricerca del passato perduto You Tube rappresenta una prima tappa, un possibile punto d’ingresso per la ricerca che ci attende. Infatti, sulla piattaforma di videosharing si possono scegliere diversi tipi di filmati che hanno i videogiochi come oggetto. Si va dai commentary degli youtuber più famosi, fino ai cosiddetti longplay, ovvero clip che mostrano un videogame giocato dall’inizio alla fine e completato al 100%. In mezzo ci sono altre categorie, ad esempio i walkthrough (le guide passo per passo per finire un gioco), i time attack (sfide in cui si cerca di finire un gioco nel minor tempo possibile) o i full/all/whole perfect (ovvero partite in cui i giocatori terminano il gioco ottenendo il maggior punteggio possibile o senza subire danni).
L’esperienza di queste visioni solleva all’incirca le stesse emozioni che proviamo guardando un vecchio album di fotografie o un film found footage. L’esplorazione di un archivio è un modo per riattivare in noi quelle emozioni e quelle sensazioni che fino a quel momento restavano chiuse nella nostra memoria. Ma sebbene questo genere di emozione estetica sia piacevole e soddisfacente resta il fatto che si tratta di una fruizione surrogata, perché ciò che distingue i videogame sono l’immersività e l’interattività. Se vi chiedessero di osservare dall’esterno un videogiocatore intento a dedicarsi al suo passatempo preferito, probabilmente la prima cosa che descrivereste di quella persona sarebbe la sua concentrazione. Sguardo attento e guizzante, rapidissimo nel seguire gli spostamenti della moltiplicità di forme e colori che s’accendono e spengono sullo schermo davanti a lui. Muscoli tesi, schiena piegata in avanti, dita frenetiche che martellano tasti e titillano levette, incessantemente. Un videogame non si guarda, si gioca e il suo scopo è quello di farci vivere un’esperienza.
Raccolte come quelle ospitate su archive.org o progetti come il Vintage Gaming Network servono proprio a mantenere in vita la possibilità di farci vivere l’esperienza di giochi che oggi sono diventati illeggibili dai nostri hardware. È a questo scopo che sono stati sviluppati i cosiddetti emulatori, software che consentono di eseguire le istruzioni contenute in un codice scritto originariamente per un ambiente hardware differente da quello in cui l’emulatore viene eseguito. Un po’ come se le vecchie console o i cabinati del passato fossero ricostruiti in vitro all’interno dei nostri personal computer, consentendoci così di recuperarne tutti i giochi e la memoria storica e personale che intorno a essi si è sedimentata.
Per la nostra generazione di retromaniaci, minacciata dalla sparizione di una parte della propria memoria, archivi ed emulatori si traducono in una forma di intenso piacere che acquista senso solo in questa dimensione profondamente nostalgica, che caratterizza la nostra cultura. È la rassicurante consapevolezza di poter tornare indietro nel tempo, in un epoca d’oro in cui ogni cosa era perfetta, e pura. Una purezza illusoria, effimera, fittizia, che però sappiamo essere ancora lì, a distanza di un clic.