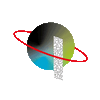I diari dello #skatemolotov: Caserta
A Caserta, per eFFe, lo skate fu il veicolo delle prima esperienza interclassista. Fu a cavallo di una tavola di legno che i ragazzini bene impararono a uscire dalla bolla sociale che gli era stata creata intorno.

A Caserta, per eFFe, lo skate fu il veicolo delle prima esperienza interclassista. Fu a cavallo di una tavola di legno che i ragazzini bene impararono a uscire dalla bolla sociale che gli era stata creata intorno.
Caserta è un sogno borghese, per chi ci vive e per chi ci si trasferisce. Io ho fatto parte di questi ultimi, avventurandomi in un trasloco di soli tredici chilometri, lungo i quali si abbandona la presa soffocante di una realtà di paura quotidiana e ci si immerge, per la Strada Sannitica Nord, nel sogno borghese di una cittadina garbata, educata, sicura, benestante.
Venivo da un paese agricolo, dove dai grandi androni dei palazzi antichi non era inusuale veder uscire carri trainati da buoi o cavalli – quei palazzi che nella corte avevano le stalle e le cantine e il forno in cui le signore di una certa età cuocevano tutti i giorni un pane che ricordo morbido e profumato. Quei forni, ho saputo molti anni dopo, utilizzavano legna tossica, carica di vernici, talvolta proveniente dalle vecchie bare che nei cimiteri si spostano per fare spazio ai nuovi morti.
Il terremoto del 1980 fu la frattura in cui questo paesaggio agricolo, duro, ma ancora vivibile, cominciò ad evolvere in quella che oggi è la seconda piazza di spaccio della droga più grande d’Italia. Già sul finire degli anni Ottanta la mia famiglia aveva capito che lì non c’era futuro, e che Caserta, quel sogno borghese che frequentavamo solo di sabato, per un cinema o delle spese, era il miglior approdo possibile.
A Caserta c’erano i negozi luccicanti, le strade erano asfaltate, c’erano i giardinetti pubblici e tutte le scuole superiori. La gente vestiva bene, di domenica andava a messa alle 11, poi beveva un aperitivo nei bar di Corso Trieste e Piazza Margherita e se ne andava infine a mangiare a casa. Per me, quattordicenne pieno di voglia di divertirsi, era una dimensione ideale.
I miei, con molti sacrifici, mi avevano iscritto nella migliore scuola della città, e i miei compagni di classe erano figli di notai e avvocati, di medici e ingegneri. Vestivano di marca, secondo la moda del momento, ma senza mai abbandonarsi ad eccessi di eccentricità, rimanendo ben saldi dentro i paletti di un’eleganza borghese: Barbour, Timberland, Nike, Levi’s, per capirsi.
Non ricordo chi cominciò e nemmeno come: ricordo solo che la novità dello skate si espanse rapidissima. Cominciò, naturalmente, come una moda, fatta di marchi ed esibizioni, e noi tutti, da buoni borghesi o piccolo-borghesi, cercammo subito di distinguerci. Io ero riuscito, tra paghette, furtarelli nel borsellino di mia madre e regali di compleanno e di Natale, a comprarmi una tavola Tony Hawk – sette strati di acero canadese – su cui avevo appiccicato il grip e montato tracks e ruote dure.
Andavamo nei giardini di Corso Trieste a far pratica e a scrivere con gli Uniposca sui muri e sulle panchine il primo slogan che avevamo imparato: “Skateboarding is NOT a crime!”. I nostri diari scolastici, i banchi e le sedie e le porte del bagno del liceo ne furono presto ricoperti. Imparammo anche che skate si poteva abbreviare con “sk8”.

Il parco del Corso era il nostro regno e si prestava bene a fare pratica di ollie e slides. Io, lo ammetto, non ero granché, ma cercavo almeno di non passare da poser, mettendoci il massimo impegno. Un giorno, dopo la scuola, trovammo che nei vialetti c’erano due ragazzi che skateavano, e non erano dei nostri: erano, giudicammo tutti, messi male: pantaloni coi tasconi pieni di strappi e buchi, t-shirt slabbrate, il cappellino girato all’indietro e delle strane scarpe nere consumate all’inverosimile sui lati esterni. Erano bravi però: senza timore prendevano possesso di tutti gli spazi, li percorrevano sullo skate, saltavano le buche con facilità.
Fu un incontro surreale: da una parte noi, i figli di papà, quelli del liceo privato, quelli con le Nike ai piedi (il fatto che i miei fossero impiegati statali e che ai piedi io avessi delle Superga qualsiasi era irrilevante), fermi a guardarli, più imbambolati per le acrobazie che gli vedevamo fare che per l’improvvisa occupazione di uno spazio che reputavamo nostro; dall’altra loro, solo in due, così agili, così sorprendentemente liberi.
Quasi venticinque anni dopo quel giorno io questo ricordo: che quel che mi sorprese fu il modo in cui, skateando, esercitavano una libertà che era fisica – nei percorsi scelti, nella capacità d’immaginare nuove evoluzioni rispetto a quelle che noi ormai ripetevamo senza sosta nei soliti angoli, nella fluidità dei movimenti, nel cadere e rialzarsi sorridendo, perché se eri caduto significava che avevi provato a spingere i tuoi limiti un po’ più in là – e che era allo stesso tempo mentale.
Lo capii quando uno dei due, un largo sorriso e una brutta acne sul volto, si avvicinò a vedere le nostre tavole. Facemmo conoscenza, i nostri timori caddero rapidamente travolti da quella facilità di approccio: venimmo a sapere che frequentava un istituto tecnico, che era stato bocciato due volte e che per questo aveva due anni più di noi, che lavorava il pomeriggio come meccanico. E che quelle scarpe devastate erano AirWalk. Capimmo che a lui interessavano le nostre tavole e quello che ci facevamo, non i conti in banca dei nostri genitori o i nostri voti nelle versioni di latino e greco. Eravamo noi i posers, non loro due. E lo capimmo tutti, anche i più ottusi mocciosi figli di papà.
Skateammo insieme per un anno abbondante. Quei due ci insegnarono tante cose, dal gergo degli skaters alle migliori marche di cuscinetti a sfera per le ruote, dall’ollie flip 180 a come invertire nose e tail; con loro scoprimmo nuovi spazi della città per skateare e ci facemmo diversi nemici tra proprietari di negozi e inquilini dei palazzi infastiditi dallo sbattere delle tavole sul marmo dei loro condomini. Alcuni di noi presero lo skate molto seriamente, migliorarono tantissimo, qualcuno si fece anche piuttosto male.
A quindici anni, in quel sogno borghese che era ed è la città di Caserta, lo skate fu per noi la prima presa di contatto con quella realtà della città che si trovava al di fuori della nostra bolla sociale, fatta di troppa prudenza, troppe convenzioni, troppa ipocrisia. Fu un ponte interclassista fatto di sette strati di acero canadese. Lo skate incrinò quella bolla borghese e per fortuna, un paio di quei ragazzini che skaetavano con me, misero la testa fuori e piano piano cominciarono ad uscirne. Mi piace pensare che se la mia vita ha preso una piega diversa e lontana rispetto a quella che era stata disegnata da altri per me, lo devo un po’ anche allo skate, e a quella lezione di libertà che lo skate mi diede nel 1990-91, nel parco di Corso Trieste, a Caserta.