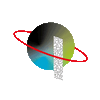Qu’est-ce qu’un blog
Sulla militanza e sul denaro.
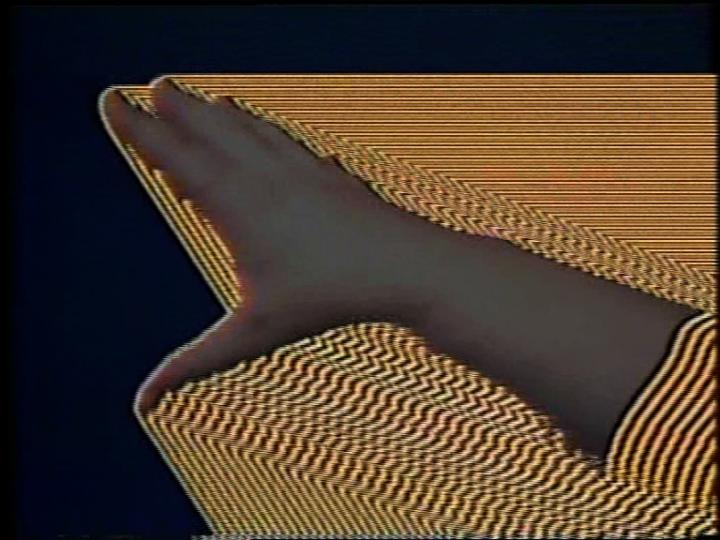
Bookblog e lavoro culturale: le coordinate di un dibattito
Sabato 23 novembre a Milano nel corso di Librinnovando si è svolto un panel dedicato ai bookblog di cui facevano parte eFFe, Christian Raimo (minima&moralia), Marco Liberatore (Doppiozero), Stefano Salis (Sole 24 ore) e Alessandro De Felice (Rivista Studio).
Questo evento fa parte di un percorso di riflessione sui bookblog che eFFe ha inaugurato con I bookblog. Editoria e lavoro culturale, il suo ebook autopubblicato. Una riflessione che è proseguita durante il Salone del Libro di Torino, negli spazi di Book to the future ed è infine approdata a Milano.
Purtroppo non ero presente ma ho potuto seguire alcuni passaggi del panel su Twitter, da cui emergeva come l’argomento principale fosse quello della sostenibilità.
Riconosciuto il ruolo imprescindibile che i blog hanno nel dibattito culturale si afferma la necessità di capire quali modelli economici potrebbero sostenere l’attività dei blog. Non è una domanda a cui è facile trovare risposta, anche perché l’oggetto della discussione è quanto mai sfuggente.
La definizione di blog si applica ormai a realtà distanti anche anni luce le une dalle altre: si va dal semplice diario personale fino alla rivista con una vera e propria struttura redazionale. Lo stesso discorso vale per i bookblog, un termine che non indica più soltanto i blog che parlano di libri, ma realtà complesse in grado di orientare il dibattito culturale.
Realtà che nel loro percorso incrociano, a volte pericolosamente, le strategie di comunicazione aziendale. Strategie che vedono nel lavoro dei blog uno strumento per ottenere visibilità in una logica di economia del dono.
Ecco dunque che il gioco s’arricchisce di un ulteriore elemento; ci sono i blog che hanno un ruolo nel dibattito culturale, c’è la necessità di trovare un modo per sostenere questo lavoro e ci sono delle prassi di marketing ormai consolidate.
I limiti della militanza e lo sfondamento dei blog
Dopo aver partecipato al dibattito, Christian Raimo ha pubblicato su minima&moralia un bel riassunto per punti di quanto si è detto durante il dibattito.
Dei 18 punti individuati da Raimo m’interessa ragionare in particolare su uno, il sesto, in cui si dice:
Io sostenevo anche che c’è una parte del lavoro culturale che facciamo che è gratuito perché è militanza, ed è per me fondamentale. Che questa parte del nostro tempo che, da intellettuali, spendiamo per formarci, formare, confrontarci, discutere, lottare, è di fatto lavoro, ma è di fatto anche militanza, ed è il modo in cui fa politica un intellettuale in genere.
A mio avviso, se discutiamo della sostenibilità di un progetto culturale, c’è un limite proprio nel concetto di militanza come dovere a cui l’intellettuale è chiamato dalla sua posizione di produttore di pensiero critico. Se i blog fanno parte di questo ambito allora è impossibile, o quanto meno molto difficile, pensarli come degli strumenti che possano essere monetizzati, perché di fatto non fanno parte del proprio lavoro, ma ne rappresentano un extra.
Qualcosa che possiamo concederci dentro, fuori e a volte contro il lavoro con cui acquistiamo la libertà di essere militanti. Una libertà a cui è senza dubbio difficile rinunciare ma sulla quale non è possibile costruire forme stabili di sostenibilità economica del proprio lavoro.
La militanza è lavoro gratuito e quando non è coatto, come lo è la militanza, il lavoro gratuito si chiama volontariato.
Storicizzando questa è un’impostazione comune a molti di coloro che ha vissuto la loro iniziazione al web e ai blog negli anni d’oro di Nazione Indiana (o almeno molte delle persone che io conosco e che hanno questa visione hanno anche fatto quel percorso).
Quello che invece affascinava me dello strumento blog non è stato soltanto la possibilità di esprimere la mia militanza all’interno di un dibattito o di una scena culturale. Per me il blog è sempre stato uno strumento finalizzato ad affinare e a favorire il riconoscimento di competenze, in un’ottica non solo militante ma ampiamente professionale e professionalizzante.
Per questo ho meno prudenze rispetto a Raimo quando si parla di pubblicità o di stringere rapporti con le aziende. Di come questo rapporto sia tutt’altro che pacificato mi pare sia esemplare il modo in cui in Italia viene stigmatizzato il concetto di native advertising. Che se va bene è descritto come marchetta; non che nella maggior parte dei casi sia qualcosa di diverso, ma native advertising per me è anche quello che Reebok ha fatto sponsorizzando Vice e dando vita a The Producer una miniserie di documentari corti su alcuni dei più famosi produttori di musica elettronica italiani.
E qui entra in campo un concetto che mi sta parecchio a cuore: la consapevolezza. L’aspetto dei blog che più mi ha conquistato in questi anni è l’esigenza di autoformazione che questi richiedono. Far crescere la propria presenza in rete significa imparare a capire come funziona per poterne sfruttare le potenzialità minimizzandone i rischi.
Un blogger deve imparare a distribuire efficacemente i propri contenuti, a farli trovare dai motori di ricerca, a formattarli in modo da renderli fruibili, a scriverli con uno stile che, adattandosi al mezzo, li possa valorizzare.
Intraprendendo questo percorso ho finito per sfondare i limiti della militanza per trovarmi nelle mani un vero e proprio lavoro.
Decostruire l’ideologia del marketing
Avere la consapevolezza che i blog siano uno strumento di formazione professionale significa essere più preparati a gestire il rapporto con le aziende.
Un ulteriore passo avanti in questo senso lo potremmo fare quando avremo smontato il discorso dominante nel marketing che considera il blogger come un amatore a cui il brand o l’azienda regala qualcosa in cambio di visibilità (ovvero il sistema del dono che stigmatizzava eFFe nel suo libro).
Più aumenta da parte dei blogger la consapevolezza del loro ruolo di attori della cultura e della comunicazione, più potranno sviluppare quella sana arroganza necessaria a riconoscere che, nell’ecosistema della comunicazione digitale, il loro lavoro vale in quanto loro e non in quanto lavoro fine a se stesso.
Quando lo scorso anno gli organizzatori di Che-Fare mi hanno chiesto di fare da influencer per il loro progetto sapevano che c’erano molte altre persone in grado di produrre contenuti e dare visibilità al progetto. Ciò che avevo in più era il mio stile (brand) personale, qualcosa che valeva la pena di coinvolgere e ricompensare.
Questo mi è parso un modello sostenibile per il lavoro dei blog nelle reti di comunicazione. Un modello che permette di declinare la militanza in forme di (auto) apprendimento e riconoscimento dell’investimento professionale necessario a padroneggiare strumenti che hanno un costo all’ingresso praticamente nullo e sono per questo motivo estremamente disponibili, permeabili e orizzontali (almeno in potenza).