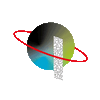Le metriche dell'indignazione
Sul ruolo delle azioni sociali nella comunicazione digitale.
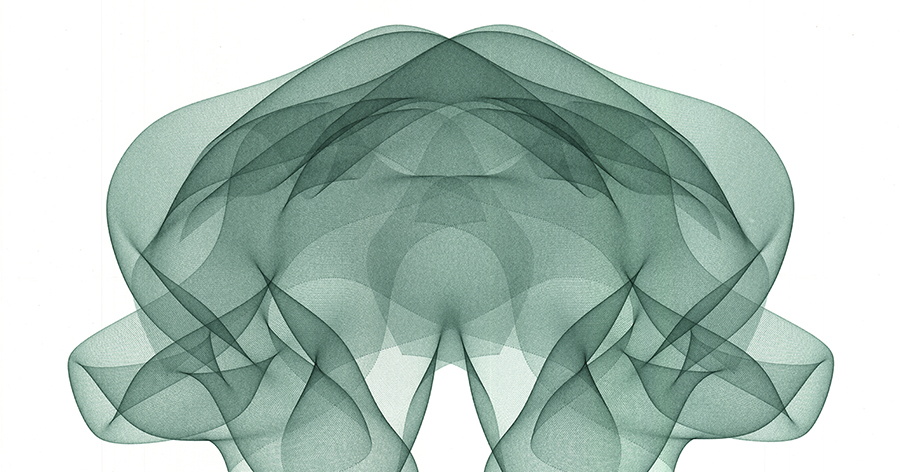
Informazioni e metainformazioni: tutto è misurabile
L’information overload o sovraccarico informativo è una delle condizioni che caratterizza la nostra vita all’interno degli ecosistemi digitali ed è reso possibile dalla progressiva diminuzione dei costi di pubblicazione e distribuzione dei contenuti.
La produzione di informazione digitale non si limita alla possibilità di creare nuovi contenuti, ma è accompagnata da un’altrettanto consistente produzione di informazione a livello meta: i cosiddetti metadati. Ovvero informazioni che accompagnano altre informazioni, specificandole, chiarendole, tessendo loro intorno ulteriori livelli di senso.
Sono proprio questo genere di dati, prodotti volontariamente dagli utenti, che garantiscono la totale misurabilità di ogni aspetto del digitale.
Ne consegue che la capacità di leggere e interpretare questi dati è essenziale per un gran numero di soggetti: dai responsabili degli uffici marketing che cercano di capire i pattern di comportamento dei consumatori fino alle agenzie di intelligence che controllano la popolazione alla ricerca di possibili minacce alla sicurezza (con tutti i rischi per la privacy e gli abusi che questo comporta).
Dittatura delle metriche: il sonno da prestazione genera mostri
In un post su Vice di qualche giorno fa, Mike Copyranter Duffy si domandava “perché ci sono così tanti imbecilli tra i social media manager?”.
Domanda a cui ha provato a rispondere Gianluca Diegoli in un post su [mini]marketing, il suo blog. Diegoli dice:
A loro volta, le agenzie incentivano queste pratiche, perché il marketing manager le valuta a secondo dell’engagement effimero che portano (è comodo valutare le cose comode, è scomodo valutare le cose importanti), il quale a sua volta è valutato da un CEO che spesso non sa nemmeno di cosa parliamo, ma ha bisogno di numeri da portare al convegno o al CDA, in cui risulti che il “dialogo con i consumatori” è stato finalmente attivato. Credo che sia difficile smentirmi, ma fatelo pure.
Questo tipo di ragionamento è quello che io chiamo “dittatura delle metriche” ovvero la riduzione di ogni azione che avviene sul digitale al giudizio delle metriche. Tuttavia queste metriche non sono mai neutre nei dati che riportano, ma sono formattate dall’architettura della piattaforma di cui devono misurare le prestazioni e sono limitate dal tipo di azioni che questa permette agli utenti.
La stupidità del social media mangement denunciata su Vice da Mike Duffy è dunque figlia di una cieca rispondenza alle metriche imposte dalle piattaforme e di una mentalità che ricerca la prestazione misurabile ad ogni costo.
Con questo non voglio dire che la misurazione delle prestazioni di un prodotto digitale (che sia un sito o un profilo sui social network) sia inutile o sbagliata. Ma soltanto che questa va legata sempre a un obiettivo di respiro più ampio che aiuti a dare un senso ai numeri ed eviti che i numeri siano il senso.
Inseguendo la prestazione fine a se stessa il rischio è che questa finisca per determinare e modellare i contenuti che produciamo. L’ormai famigerata colonna di destra di Repubblica.it è un esempio chiaro di come il sonno da prestazione generi mostri.
Mostri che diventano facilmente un habitus mentale capace di condizionare profondamente ogni attività.
Follow the money: lo stretto rapporto tra metriche e business model
Il ruolo a volte preponderante che le metriche assumono nell’editoria digitale (ma non solo) è legato al loro stretto rapporto con i business model più diffusi.
Oggi, dopo una lunga fase pionieristica e di esplorazione, la nostra cultura può dirsi pienamente digitale. Tuttavia i modelli di socialità e quelli economici non sono ancora chiaramente definiti e soprattutto non sono ancora pienamente digitali ma stanno guadando il fiume che li separa da quelli nuovi. O meglio da quelli che verranno creati e consolidati nel prossimo futuro.
Il modello pubblicitario che oggi caratterizza la maggior parte dei news brand, mutuato direttamente dalla cultura analogica, è un perfetto esempio di come sta avvenendo la transizione.
Il valore di un marchio per gli inserzionisti è determinato in base alle metriche di accesso (utenti unici, impressions), da quelle di coinvolgimento (tempo di permanenza sul sito, interazione coi contenuti) e dalle metriche social (apprezzamenti, condivisioni).
C’è quindi un rapporto diretto tra queste metriche e il valore di un brand sul mercato pubblicitario. Un rapporto che spesso incide sulla qualità dei contenuti proposti che viene sacrificata sull’altare della prestazione.
Oggi discutevo con un amico giornalista di un post pubblicato sul sito per il quale lavora. Il post riguardava un argomento che risulta privo di qualsiasi credibilità. Un po’ scherzando un po’ no il mio amico mi faceva notare che il post aveva prodotto un elevato numero di accessi e commenti al sito. Di rimando gli facevo notare che questo è un vantaggio sul breve periodo, ma che sul lungo periodo il rischio era quello si svalutare il brand facendogli perdere credibilità e autorevolezza (che nell’economia di un sito di news non sono tutto ma sono moltissimo).
Superare questa impasse significa sperimentare coi modelli di business cercando soluzioni nuove che dimostrino una più profonda comprensione di come funziona la cultura digitale. Gli esempi ci sono e anche se formule stabili non esistono ancora ci sono numerosi spazi di intervento.
Le metriche dell’indignazione: come possiamo influire sui contenuti
Sarà capitato anche a voi di trovare tra gli stream dei vostri social network o di condividere voi stessi contenuti che suscitano indignazione: una riflessione qualunquista, un editoriale razzista, una bufala goffa, una notizia sciocca e irrilevante.
È questo il modo giusto per dimostrare la vostra disapprovazione rispetto a un argomento? Il ragionamento sul rapporto tra metriche e modelli di business dovrebbe suggerirvi che la risposta è no, puntare il dito su un contenuto che suscita indignazione mettendolo in circolo nei vostri social network non è il modo giusto per stigmatizzarlo.
Così facendo infatti lo inserite in quel circuito di azioni sociali che ne determinano la fortuna e soprattutto la perpetuazione.
Infatti se un contenuto fa registrare buone prestazioni c’è un’ottima probabilità che argomenti analoghi verranno riproposti in futuro, perché funzionano all’interno dei sistemi di misurazione che oggi determinano il valore di un news brand agli occhi degli inserzionisti pubblicitari.
Dunque come possiamo far inceppare questo meccanismo? Come possiamo lavorare dentro e contro l’appiattimento del senso sulle metriche che misurano la performance di un contenuto digitale?
Privare quel contenuto dei segnali che gli sono necessari per sopravvivere e prosperare all’interno degli ecosistemi digitale è una contromisura che abbiamo a disposizione.
Non condividere, non cliccare, non commentare. Non contribuire con le nostre azioni sociali alla crescita di quel contenuto è una strada per isolarlo o quantomeno per non contribuire a fare di quel contenuto un frammento di valore per chi lo ha creato e diffuso.
Non è molto e di certo non è abbastanza ma indubbiamente cominciare a ragionare in questo modo serve a renderci più consapevoli del modo in cui le nostre azioni possono influenzare la fisionomia delle reti e degli spazi digitali che abitiamo ogni giorno con sempre maggiore assiduità.