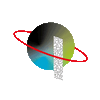Sbirri, cops, bullen, flicks. Riflessioni a caldo sul film di Roberto Burchielli
*Sbirri* di Roberto Burchielli mette in scena il rapporto tra la realtà e la finzione giocando con il carattere attestativo e riproduttivo del mezzo cinematografico.

Sbirri di Roberto Burchielli mette in scena il rapporto tra la realtà e la finzione giocando con il carattere attestativo e riproduttivo del mezzo cinematografico.
Martedì la prima serata di Canale 5 proponeva il film Sbirri (2009) di Roberto Burchielli, con Raoul Bova nella doppia veste di produttore e protagonista. Alla visione del palinsesto su di un quotidiano mi si è illuminata una piccola zona della memoria. Circa un anno fa vidi uno speciale dedicato a questo film, uno di quei backstage pubblicitari che spesso passano alla televisione. Ricordavo un Bova goffamente mascherato (con baffi, barba e capelli lunghi come solo nei film si vedono) andare in giro per Milano insieme ad alcuni poliziotti, gli Sbirri del titolo, di un'unità antidroga metropolitana. Lo speciale faceva pensare ad una specie di documentario o, al limite, un mockumentary.
Ho deciso perciò di seguire il film in parte incuriosito e mosso da un piacere voyeuristico, in parte interessato a capire quali strategie di rappresentazione di un settore della forza pubblica (quello volto alla repressione della microcriminalità legata al consumo ed allo spaccio di droga)che spesso è stato al centro di aspre polemiche negli ultimi anni (la morte di Stefano Cucchi è stato solo il caso più mediatizzato). Dopo pochi minuti di visione ho capito che le mie curiosità sarebbero rimaste inevase: il film è si un mockumentary, ma è completamente incentrato sulle vicende di un reporter dal vastissimo curriculum, Matteo Gatti (Raoul Bova), famoso per "metterci la faccia", per assicurare, con la sua (bella) presenza la veridicità dei fatti documentati (di lui si dice, in un profilo che vediamo apparire nelle immagini di un telegiornale, che ha passato anche del tempo in un CPT, oltre ad aver collaborato alla cattura di alcuni terroristi).
Gatti, in seguito alla morte del figlio a causa di una pasticca, decide di recarsi da Roma a Milano, dove, col pretesto di documentare la realtà della droga nella città meneghina, vuole cercare informazioni sullo spacciatore che ha ucciso suo figlio. Non voglio tralasciare come in questo melodrammone fin "troppo italiano" i sentimenti sono sempre di un'intensità lacerante che sfiora a volte l'osceno (quando sono espressi dall'attrice Simonetta Solder, che interpreta Sveva, la moglie di Gatti) a volte il ridicolo (quando ad esprimerli è Matteo)
Al di là di queste annotazioni, ciò che del film mi ha colpito, ed è l'oggetto di questa riflessione, è la dialettica tra le immagini attestative (reali, documentarie) e quelle configurate (finzionali, filmiche). A dominare tanto le prime, quanto le seconde è un'estetica sporca: immagini sgranate, mosse, inquadrature prese da dietro gli angoli, scorci audaci e volutamente lontane dalle regole di ripresa professionale.
Insomma, fin dalla scelta dello stile di ripresa il film grida il suo realismo, si dichiara essere realistico, a tratti (laddove vengono presentate immagini ottenute tramite le telecamere di sorveglianza della Polizia, o nel corso delle azioni a cui il buffamente camuffato Raoul Bova partecipa) reale. Naturalmente il realismo qui è tutta una questione di stile, che nulla ha a che fare con la realtà che il film vorrebbe raccontare. L'effetto che si ottiene nelle ricerca del realismo è però quello di rendere quasi indistinguibili i due regimi di significazione entro cui il film è costruito, quello attestativo e quello configurativo, si passa, infatti, dall'uno all'altro senza scarti evidenti. In un certo senso, seppure l'intera operazione si presenta sotto il marchio della fiction, della finzione, l'intento del regista è quello di ridurre la percezione di essa al minimo consentito dalla flessibilità del mezzo cinematografico.
Tale meccanismo giunge al parossimo nella scena in cui, prima di un'irruzione all'interno dell'appartamento di uno spacciatore, Bova-Gatti è inquadrato con una videocamera in mano. Si tratta di un segno che serve ad attestare la reale presenza di Bova all'interno della scena, ma è, allo stesso tempo, un elemento del tutto incongruo nelle mani del personaggio che sta interpretando, che bisogno avrebbe Gatti, dal momento che è sempre seguito, anche nei momenti più intimi o difficili, dall'operatore Gino (che non vediamo mai, ma la cui presenza si fa "sentire" in ogni occasione), di raddoppiare la sua visione con una videocamera? Nessuno, quella videocamera serve a ricordare allo spettatore che quella scena è accaduta davvero, che Raoul Bova e non Matteo Gatti è stato lì.
È evidente il cortocircuito che si viene a creare, in quanto il regime attestativo risulta del tutto omogeneo a quello configurativo. Non vi è differenza, non vi è alcuno scarto tra le immagini che permetta allo spettatore di collocarsi all'interno di esse per lavorare coi suoi strumenti cognitivi la realtà che si cerca di raccontare.
Allo stesso modo è trattata la droga: non fenomeno complesso di cui si ricercano le cause, le connessioni, le connivenze, bensì semplice presenza immanente alla vita di una città, Milano, che rappresenta, per metonimia, il paese intero. Presenza e non costruzione sociale, dato di fatto e non fenomeno passibile di comprensione nei suoi concatenamenti sociali, la droga ha, nel film, un'esistenza propria, autonoma, sembra prodursi per generazione spontanea e non essere il riflesso di un'articolazione economica e di potere, come, in realtà, essa è. "Io so che è solo una goccia nel mare", sentenzia Angelo, l'ispettore-angelo custode di Bova-Gatti "ma stasera io ho tolto dalla strada 50 pezzi, e questo mi basta"...suona ragionevole, ma è una dichiarazione di resa, si può vincere una battaglia, non la guerra.